LETTERATURA, TEATRO E MONDO DEL LAVORO NELLA NAPOLI PRE E POSTINDUSTRIALE
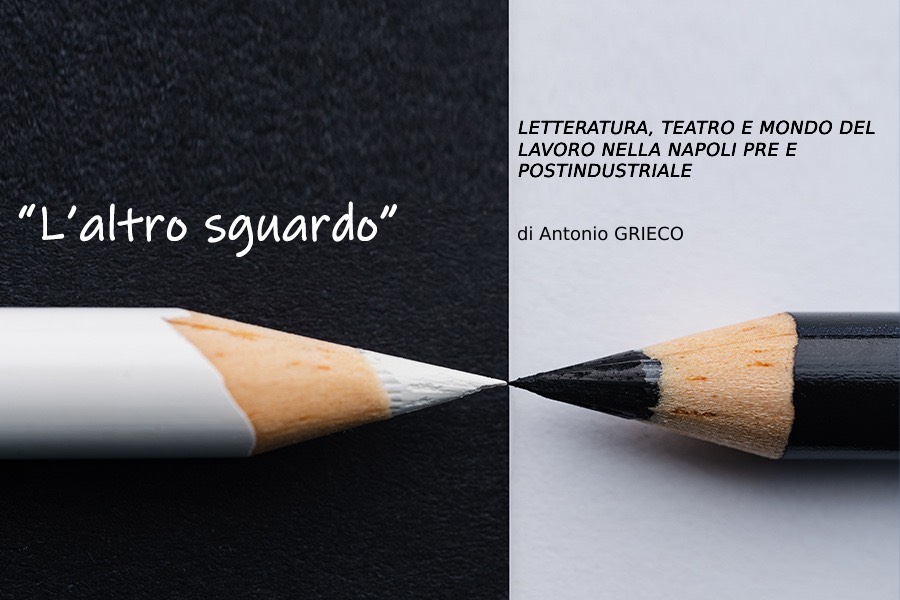
di Antonio GRIECO
Lei deve sapere che montare una gru è un bel lavoro, e un carro–ponte
ancora di più, però non sono mestieri da fare da soli…
Primo Levi, La chiave a stella.
La rivoluzione industriale e sociale che a Napoli si accompagnò alla fase pre e post-unitaria, ha avuto riflessi molto limitati nella letteratura napoletana tra Otto e Novecento. Solo in Mastriani – tra i grandi padri del verismo sociale europeo spesso scambiato per un innocuo autore di feuilleton – incontriamo prime narrazioni di un mondo del lavoro stabile di cui nell’Ottocento si conosceva poco o nulla. Così, ad esempio, leggendo Le ombre. Il romanzo sul lavoro femminile a Napoli nell’800 (1868), uno dei suoi lavori più intensi e drammatici, scopriamo (e siamo intorno al 1844!) che «quel dì era stato giorno di sciopero anche per la povera Rita Damiani, cucitrice di lembi e di frappe nei magazzini di Madame G… a Chiaia»(1). Sempre da Le Ombre, che «richiama la tecnica cinematografica del piano sequenza e lo stile biblico»(2),apprendiamo ancora che le apprendiste non ricevevano alcun compenso ed erano sfruttate al pari delle altre operaie che ricevevano comunque un salario di fame, assolutamente non proporzionato alla loro straordinaria abilità. Ma la cosa che più colpisce in questo romanzo è l’ apertura dello scrittore napoletano ai temi della modernità, come nel capitolo La filanda di Sarno in cui descrive minuziosamente l’organizzazione del lavoro di questo opificio all’avanguardia in provincia di Salerno – dove lavorano un migliaio di operai di ambo i sessi e fanciulle di appena dieci anni – sostenendo, in conclusione, la decisiva funzione delle macchine per rendere meno faticoso il lavoro operaio(3). Si può comunque considerare quest’opera, apparsa sui giornali in appendice, ancora oggi un raro documento di indagine sia sul proletariato napoletano che sulla condizione delle donne in fabbrica, immediatamente a ridosso de l’Unità d’Italia; per queste ragioni ci sembra condivisibile l’osservazione di Antonio Palermo, secondo cui Mastriani «nell’ultimo decennio borbonico ha pagato un elevato prezzo politico per queste libertà sociali che si prendeva nei suoi romanzi»(4). Ma lo scrittore, amatissimo dal suo popolo di cui, come osservò Giovanni Bovio alla sua morte, «ne descrisse mestieri ed attività volte a procurarsi il minimo necessario per la sopravvivenza»(5), con la sua “letteratura militante” (che in qualche modo richiama la chiara posizione di Mazzini contro ogni forma di discriminazione di genere(6)) resterà un caso isolato, e per molti anni la letteratura nella capitale del Mezzogiorno, se si esclude Matilde Serao con la sua «scrittura come progetto di verità»(7), non si occupò dei non irrilevanti mutamenti scaturiti, ad esempio, dal nittiano piano di sviluppo della Società per il Risanamento di Napoli, approvato nel 1885; un programma di investimenti che in qualche modo cercò di porre un argine alla grave condizione delle classi meno abbienti dopo l’epidemia di colera del 1884; provvedimenti che, tuttavia, anziché produrre i benefici sperati, finirono, come è noto, per accrescere il malessere dei ceti cittadini più bisognosi, presentandosi come interventi mirati per gran parte alla ristrutturazione edilizia del centro storico. E il popolo, quel popolo che, come osservò la Serao, era stato tradito, ora veniva respinto dietro il paravento(8). Del resto, sarà proprio lei, la Serao a sollecitare l’attenzione del governo di Agostino Depretis sullo “sfasciume sociale” e a recuperare l’immagine della città dell’ultimo quindicennio del secolo(9). Bisogna in ogni caso qui tener presente che dopo la sconfitta borbonica non mancarono in città segnali di un diffuso malcontento popolare che lasciavano intravedere sullo sfondo prime adesioni alle idee di emancipazione socialiste: ma il nuovo mondo, quel mondo del lavoro scaturito dalle scoperte scientifiche e tecnologiche dell’Ottocento, salvo rare eccezioni, sembra pressoché assente nella narrazione dei nostri scrittori: dai drammaturghi (se teniamo conto delle ormai storiche ibridazioni tra letteratura e scrittura teatrale(10)), ai poeti più famosi che ebbero comunque il merito di elevare la comunicazione non verbale a vera e propria lingua(11). Eppure, qualche buona ragione per alludere a un quadro più dinamico della società napoletana del tempo ve n’era, se si pensi che «accanto allo sciopero episodico dei lavoratori di bottega, vi fu lo sciopero generale di 1500 calzolai del 1896 (tra lavoranti di bottega e operai di fabbrica), ci sono alcuni cicli di lotta nei vari rami di lavorazioni delle pelli»(12). Certo, è qui indubbio il peso strutturale che in tale trasformazione produttiva assunse la legge speciale per Napoli approvata dal governo l’8 luglio 1904, grazie alla quale «Napoli diventerà comunque la quarta città industriale del paese»(13). In definitiva, possiamo facilmente constatare come sul finire del secolo diciannovesimo nella poesia napoletana – non diversamente dalle splendide canzoni ad essa indissolubilmente legate – non vi siano che trascurabili echi di quel processo innovativo dell’industria che favorì la nascita nella zona orientale di Napoli dei primi nuclei organizzati di classe operaia; una presenza attiva della forza lavoro nel vasto territorio metropolitano partenopeo che spiega forse la ragione per cui per la prima volta nella storia moderna della città la camorra, che aveva avuto un ruolo decisivo nelle rivolte dei secoli passati, nei moti del maggio del 1898 in città non ebbe alcun peso, anche se essa conservò tutti i caratteri dell’antica plebe napoletana(14). È vero che la comunità operaia viveva allora in aree “depresse” molto distanti dal centro urbano, ma è davvero non semplice da spiegare – al di là della coraggiosa “inchiesta” di Pasquale Villari con le note Lettere meridionali (1875) e della Serao che, sulle tracce di Mastriani, nel suo famoso reportage letterario non mancò di informarci anche del diverso trattamento degli operai del Sud da quelli del Nord («gli operai tipografici sono pagati un terzo meno degli altri paesi»(15)) – il motivo per cui di questo nuovo processo socio-economico vi siano così scarsi riferimenti nelle opere dei nostri più importanti scrittori vissuti a cavallo dei due secoli. Per trovare nell’immaginario artistico echi di questo profondo mutamento, dovremo volgere lo sguardo soprattutto a Roberto Bracco e Raffaele Viviani: col primo, drammaturgo e novelliere di respiro europeo, che insieme ai caratteri della nuova borghesia meridionale indagò la condizione delle donne nella società di fine secolo, e il secondo che documentò (con “candore”) lo sfruttamento selvaggio della forza lavoro, in quella che Karl Polanyi avrebbe poi chiamato La grande trasformazione(16). Ai due grandi commediografi, sarebbe giusto affiancare Ferdinando Russo, il poeta degli ultimi, degli scugnizzi, che – dopo aver mostrato evidenti simpatie borboniche col poemetto ‘O luciano d’ ‘o Re – aveva aderito al partito Repubblicano nel 1892. Dopo il verismo documentario russiano, c’è appunto Viviani col suo crudele realismo, in poesia come nella scrittura scenica; un teatro indissolubilmente legato alla vita del popolo (dove la musica è un elemento assolutamente non marginale di una invenzione drammaturgica che anticipa le più audaci sperimentazioni teatrali novecentesche), che ci guida nelle più laceranti contraddizioni della Modernità. Sarà lui, l’autore attore di Castellammare – in una inedita formalizzazione scenica che mescola tradizione e innovazione, a svelarci una umanità dolente che deve fare i conti ogni giorno con nuove, odiose forme di oppressione del potere economico e politico: «Il nostro Viviani resta un teatro di povera gente che si sforza di dichiarare – non di rivendicare – questo mi sembra importante – i propri diritti; diritti alla libertà dell’intelligenza, alla libertà del lavoro, alla libertà dell’esistenza in un senso pienamente umano»(17); a cominciare, potremmo aggiungere, dalla vita dei nomadi, dei migranti, di uomini e donne costretti ad abbandonare le proprie terre per sfuggire a fame e guerre. E poi c’è il mondo invisibile degli operai, cui Viviani si avvicina con un commosso rapporto di empatia: come nella poesia Fravecature, che ci introduce nella drammatica condizione della “working class” meridionale agli inizi del secolo attraverso un episodio di drammatica attualità: «l’incidente del muratore Ruoppolo morto tragicamente dopo essere scivolato dall’andito di un palazzo in costruzione ai Vergini, uno dei quartieri più popolari a Napoli e luogo di ambientazione di numerosi testi vivianei»(18). Anche in altre poesie, come a Canzone d’ ‘a fatica, ’O canto d’ ‘o ferraro, Faticanno sott’ ’e sghizze e ’O canto do manganiello, ci imbattiamo in una vivace rappresentazione poetica del mondo del lavoro(19). Ma, come accennavamo, qualche anno prima di Viviani, a questa radicale mutazione della società napoletana guarda anche Bracco, che scava nella nascente borghesia imprenditoriale meridionale svelandone tutto il suo feroce cinismo nel dramma Il diritto di vivere (1900), incentrato sulla triste storia dell’operaio Antonio Altieri, che, costretto al furto per non soccombere alla miseria, è ingiustamente licenziato. Scoperto dalle guardie e incapace di sopravvivere alla sua colpa, egli deciderà di mettere fine alla sua vita suicidandosi. Pur nell’accento melodrammatico – che si riflette nelle lacrime della prostituta Nannina e fa pensare al Mastriani di Arlecchino (1873)(20) – lo scrittore napoletano ci fa scoprire appunto un’altra dimensione della vita napoletana, quella della periferia industriale della città che soltanto più tardi sarà oggetto di attenzione da parte di scrittori e sociologi meridionalisti. Crediamo sia giusto qui ricordare che Viviani è stato tra i rari uomini di teatro del primo Novecento a comprendere il carattere innovativo delle opere dell’autore de Il piccolo santo (1912), mettendo in scena, nel 1938, Maschere, un atto unico del 1893, che analizza con freddezza la perdita di senso di una società interessata esclusivamente al profitto. Dunque, Napoli, pur se in tono minore rispetto ad altre città italiane ed europee, è, come abbiamo visto con Bracco e Viviani e prima ancora con Mastriani, investita agli inizi del Novecento – e già in anni che precedono la costruzione del siderurgico di Bagnoli – da strutturali trasformazioni che daranno vita a comunità sempre più consapevoli della loro decisiva funzione sociale nel nuovo scenario globale. Per trovare nella letteratura meridionale riflessi meno episodici di questa inedita (e oscurata) realtà metropolitana, dovremo attendere Carlo Bernari, che ambienta nella Napoli industriale dei primi decenni del Novecento il suo primo romanzo Tre operai, (edito da Rizzoli nel 1933, in una collana a cura di Cesare Zavattini), dove al vissuto di tre operai (Teodoro, Marco ed Anna) fa da cornice il drammatico stato delle classi meridionali disagiate durante il fascismo. Anche l’intreccio narrativo è qui assolutamente innovativo, lontano dalla Napoli folclorica tanto cara al regime. A partire dal vissuto di Teodoro, giovane operaio sindacalista, amico di Marco, che conosce Anna ma è al tempo stesso attratto da sua sorella Maria. Il testo di Bernari – un’anticipazione del Neorealismo che vedrà una trasposizione teatrale ad opera di suo figlio, Enrico Bernard – prende la sua definitiva forma narrativa dal dattiloscritto Gli stracci, un abbozzo nato con l’idea «di mostrare come l’industria sia qualcosa che pervade tutta la letteratura senza che si debba parlare di ciminiere o fabbriche»(21). C’è da dire che l’origine di questo originale romanzo di insolita ambientazione napoletana, è molto intrecciata alla storia stessa dei Bernard (il nome Bernari è solo uno pseudonimo dello scrittore), una famiglia di imprenditori proprietari di una azienda ubicata nell’area orientale della città. Lo scrittore lavora per qualche tempo anche nell’impresa famigliare ma poi decide di seguire la sua naturale inclinazione, la scrittura, approfondendo gli studi e accostandosi ad un gruppo di artisti e intellettuali napoletani come Guglielmo Pierce e Paolo Ricci, con i quali elabora il “Manifesto dell’U.D. A”(22) (Unione Distruttivisti Attivisti), considerato dal critico Filiberto Menna, un testo sull’arte di assoluto respiro europeo(23). Per riscoprire la presenza attiva della classe lavoratrice nelle opere dei nostri autori, dobbiamo giungere al 1945, quando Eduardo De Filippo mette in scena Napoli Milionaria!, dove protagonista è l’operaio Gennaro Iovine, che al ritorno dal fronte trova i suoi familiari coinvolti in ripugnanti traffici illeciti che li spinge in breve tempo sull’orlo di un inarrestabile degrado morale. Vittorio Viviani ricorda che in un primo momento Eduardo intendeva trattare questa commedia con l’umorismo farsesco dei suoi precedenti lavori, ma «al ritorno nella sua città, rimase smarrito, stravolto dagli avvenimenti più grandi di lui»(24). Insomma, la guerra crea in Eduardo un profondo turbamento interiore che lo spinge a rivedere il suo iniziale progetto, dando così vita con Napoli Milionaria! ad una decisa svolta della sua drammaturgia. Così, se nella prima stesura del testo il protagonista veniva molto probabilmente coinvolto anch’egli nelle attività illegali (dal contrabbando all’usura) dei suoi cari, ora, nella versione definitiva, Eduardo lo trasforma in un severo giudice del proprio microcosmo umano, che aiuta lentamente a rinascere dall’abisso in cui era tristemente precipitato. Su queste basi, sulle tracce cioè di un immaginario che non sfugge alla Storia, nasce, come sappiamo, il Neorealismo, di cui, pur con i suoi limiti didascalici, non si può negare – soprattutto nel cinema e nel teatro – il suo prezioso contributo nello svelarci la tragica realtà sociale del dopoguerra che il potere politico avrebbe continuato volentieri a nascondere. Ad accorgersi però che sui romanzi su Napoli c’è molto spesso solo “la miseria del popolino” ma manca quella della classe operaia, è Salvatore Cacciapuoti – antifascista e segretario nel dopoguerra della Federazione Comunista napoletana, per Ermanno Rea “il piccolo Stalin napoletano”(25)- che nel suo volume autobiografico, Storia di un operaio napoletano (Editori Riuniti, 1972), parla della necessità di rappresentare questo mondo spesso in ombra, chiuso con la loro famiglia in un riserbo dignitoso(26). La narrazione di Cacciapuoti, certo molto lontano dall’originalità letteraria de La chiave a stella(27) di Primo Levi (Premio Strega 1979) – pur nella evidente enfatizzazione del ruolo della classe operaia, ci invita comunque a scoprire una working class “invisibile” , quasi ignorata dalla letteratura napoletana del dopoguerra. Lo stesso Ermanno Rea in Mistero napoletano (1995), il suo bel romanzo dedicato alla tragica storia di Francesca Spada – suicida dopo aver subìto incredibili umiliazioni dai suoi stessi compagni di partito – è critico sull’operaismo comunista di quegli anni, ma poi deve ammettere che dopo la notte dello stalinismo, «la spinta a risorgere di cui Napoli ha bisogno, se non da lì da dove mai potrebbe arrivare»(28). Comunque, anche all’interno di questo nuovo, per nulla rassicurante scenario metropolitano da lui raccontato, del lavoro in fabbrica si parla poco. Eppure, le possibilità di cogliere un altro, più dinamico orizzonte urbano non mancavano, se anche un grande poeta come Giuseppe Ungaretti, accompagnato dal suo amico Renato Cappa – tra i fondatori della rivista “Nord e Sud” – visita negli anni Sessanta (“col suo sguardo vivissimo”) l’Ilva di Bagnoli mischiandosi ai caschi gialli e restandone letteralmente affascinato(29). Del resto, sarà proprio un poeta napoletano, Ariele D’Ambrosio, alla chiusura dell’impianto bagnolese, a rendere vivo il dolore degli operai per la perdita del loro sito produttivo, comparando in una sua lirica, negli scoppi di notte all’orizzonte – requiem urbano (1995), la dismissione dell’altoforno a un assassinio da «lupara bianca a carne mozze/ raffreddata su volti senza naso/incaprettati al fuoco di acidi dissolti/ su griglie immense/riminate in guerra degli affari»(30).
Un tema ricorrente nella letteratura napoletana del dopoguerra concerne la difficile saldatura tra la classe operaia e le classi più emarginate: un rapporto che da allora sarà sempre più segnato da fragili alleanze(31). Una difficoltà ad unire in uno stesso blocco sociale – operai, disoccupati, intellettuali progressisti – che indirettamente si può cogliere anche nei romanzi di Domenico Rea e Luigi Incoronato; soprattutto in Scale a San Potito di quest’ultimo, dove, forse per la prima volta nella nostra letteratura, si racconta la vita “separata” di un popolo di diseredati che vive come in un mondo a parte in una rampa di scale nel cuore di una grande metropoli moderna. Dunque, dobbiamo ad alcuni scrittori neorealisti napoletani il disvelamento di quelle ombre del sottosuolo che nemmeno i partiti di sinistra (socialisti e comunisti) erano riusciti ad intercettare, pur rappresentando un ineludibile punto di riferimento nelle battaglie per i diritti e la democrazia dentro e fuori i luoghi di lavoro. Crebbe così in un breve arco di tempo a Napoli, in un clima segnato dal conservatorismo laurino , la distanza tra la sinistra e quella parte del sottoproletariato che nel cuore del centro storico sopravviveva con lavori umili, sottopagati, non di rado di straordinaria qualità artigianale: come quello, molto diffuso del rione Sanità, della lavorazione (soprattutto a domicilio) dei guanti; una assoluta eccellenza napoletana di cui parlò anche Philip Roth nel suo capolavoro Pastorale americana (1997), sottolineando che i guanti ormai non sapevano tagliarli più in nessun posto al mondo «tranne forse che in qualche fabbrichetta a gestione familiare di Napoli e di Grenoble»(32). Questa estrema divisione all’interno della stessa comunità – da una parte il mondo operaio dall’altra un mondo di diseredati esclusi dalla vita sociale – si ricomporrà, se pur parzialmente, a Napoli solo alla fine degli anni Sessanta con la rivolta studentesca e operaia cui si uniranno migliaia di disoccupati organizzati , che – critici anche verso le organizzazioni sindacali – lotteranno contro il precariato e il governo per ottenere – come scrisse Fabrizia Ramondino – «un lavoro stabile e sicuro»(33). Forse, la verità sulle drammatiche condizioni di vita a Napoli negli anni del miracolo economico, possiamo invece coglierla in tutta la sua tragica attualità in Donnarumma all’assalto (1959), un romanzo autobiografico di Ottiero Ottieri(34) che ci parla di una popolazione che ha solo fame di lavoro, mentre viene respinta fuori dalla Storia da un potere politico che sceglie tra i buoni (coloro che per loro bravura hanno diritto al lavoro) e i meno fortunati, gli analfabeti, (che vengono sistematicamente abbandonati al loro destino dalle istituzioni). Lo sguardo di Ottieri ha inoltre il merito di alludere a un processo duale della società italiana, dove a un Sud ai margini della vita civile del Paese che si spopola con l’emigrazione, fa da specchio un Nord sulla via di un veloce processo d’ integrazione europea. Un romanzo che tentò di riproporre all’attenzione della nostra classe dirigente il mondo del lavoro insieme al devastante processo di deindustrializzazione del tessuto urbano napoletano negli anni Ottanta del Novecento, è stato La dismissione (2014) di Ermanno Rea, che racconta la storia di Vincenzo Buonocore, tecnico specializzato cui è affidato l’incarico di smontare l’impianto del suo reparto dopo la chiusura definitiva dell’azienda. Il testo, cui fa da sfondo l’amara sconfitta operaia, ci parla soprattutto della eccezionale abnegazione del tecnico che pensa solo a svolgere nel migliore dei modi possibili il compito che gli è stato affidato dal management aziendale. In modo molto laterale si sofferma, invece, sull’organizzazione del lavoro dello stabilimento siderurgico napoletano e sulla gravi difficoltà di rapporto tra gli stessi lavoratori e le organizzazioni sindacali. Forse, per conoscere più da vicino, attraverso la finzione letteraria, quali erano le condizioni della working class a Napoli sul finire degli anni Sessanta, prima dell’avvento della trionfante globalizzazione neoliberista, dovremo volgere lo sguardo al romanzo Storia di chi fugge e chi parte, terza parte della quadrilogia de L’amica geniale di Elena Ferrante, dove la protagonista Lila, che lavora in una piccola azienda alimentare, intervenendo in un’assemblea politica del movimento studentesco, parla così della sua recente esperienza in fabbrica: «… ignorando lo sguardo perplesso di Enzo, chiese la parola. Parlò a lungo, in italiano, mentre Gennaro le si agitava in braccio. Cominciò piano, poi tirò avanti nel silenzio generale con una voce forse troppo alta. Disse sfottendo che non sapeva niente della classe operaia. Disse che conosceva solo le operaie e gli operai della fabbrica dove lavorava, persone da cui non c’era assolutamente niente da imparare se non la miseria. Ve lo immaginate, chiese, cosa significa passare otto ore al giorno fino alla cintola nell’acqua di cottura delle mortadelle? Ve lo immaginate cosa significa avere le dita piene di ferite a forza di spolpare ossa d’animale? Ve l’immaginate cosa significa entrare e uscire da celle frigorifere a venti gradi sotto zero, e prendere dieci lire in più all’ora – dieci lire – per l’indennità freddo? Se ve lo immaginate, cosa credete di potere imparare da gente che è costretta a vivere così? Le operaie devono farsi toccare il culo dai capetti e dai colleghi senza fiatare»(35).
Qui la Ferrante – con le brevi, sferzanti parole di Lila – mette in discussione, quasi sulla stessa linea del sociologo Alain Touraine, sia un’idea della modernità(36) indissolubilmente legata a un principio di liberazione umana, che una visione (molto diffusa in quel periodo anche in parte dei nostri più acuti intellettuali) di un mondo di garantiti (quello degli operai di fabbrica) separato da quello di un sottoproletariato urbano senza storia né identità sociale. Lo sfruttamento, sembra dirci la scrittrice, di chi sta dentro e chi sta fuori i recinti di un’azienda manifatturiera, è simile, perché parte di un identico meccanismo di sviluppo fondato sull’ingiustizia sociale, sulle disuguaglianze, sulla totale assenza di diritti e di dignità umana. Ma qui la Ferrante, attraverso le parole soffocate di Lila, oltre a distruggere questo stereotipo sociologico ancora oggi purtroppo duro a morire, sembra evocare un violento potere maschilista che non ha mai smesso di avere il dominio assoluto sui corpi. Nell’orizzonte neorealistico ferrantiano si inscrive il romanzo di Maria Rosaria Selo, Vincenzina ora lo sa. Selo è una scrittrice e sceneggiatrice di cortometraggi e documentari. E questa propensione a racchiudere in un’immagine i conflitti materiali della comunità operaia, si avverte già nelle pagine iniziali della sua storia, quando evoca la rabbia dei caschi gialli nell’assemblea del 1981 con il ministro De Michelis(37). Da questo momento, la narrazione si intreccia col vissuto di Vincenzina che abbandona gli studi universitari per entrare in fabbrica come addetta alle pulizie dopo la morte di suo padre Ferdinando, causata molto probabilmente dall’inalazione per anni di sostanze nocive. Il lavoro in fabbrica cambierà per sempre la sua vita. Si prenderà ora cura di sua madre Antonietta e di sua sorella Giulia, mentre parteciperà da protagonista alle lotte contro la chiusura del siderurgico napoletano. Sperimentando in breve tempo la durezza dei ritmi e dell’organizzazione del lavoro in fabbrica: «Il lavoro è immane e si svolge su oltre due milioni di metri quadri, dove si muovono circa ottomila persone, tra operai e impiegati…subito dopo la pausa, verso le tre, c’è il ripasso dei bagni. Una volta alla settimana le tocca la pulizia dei capannoni, tra le siviere e gli altoforni. Nonostante i guanti, le mani sono piene di vescicole rosse e gonfie, le unghie spezzate, i polsi doloranti a furia di strizzare canovacci. Gli occhi e la gola le bruciano per i detersivi.»(38). Sembra la scena di un’opera ottocentesca di Mastriani, ma questa realtà del lavoro in fabbrica ci parla invece nei tempi nuovi della postmodernità dove tutto sembra apparentemente “dematerializzato”. Ciò che ci fa sentire particolarmente vivo questo romanzo – insieme all’attenzione alle dure, materiali condizioni della vita del “cantiere” – è il coraggio di Vincenzina di opporsi assieme alle sue amiche, Anna, Piera, Aurelia ed Elena, alle discriminazioni (anche sindacali) e alle violenze perpetrate nei confronti di tutte le donne dentro e fuori quel microcosmo industriale che per molti decenni rappresentò un insostituibile presidio democratico della città. Particolarmente intense e allusive le ultime pagine del romanzo, quando ritroveremo Vincenzina con le sue amiche che la festeggiano per la laurea ottenuta dopo anni di durissimi sacrifici. Intanto, sullo sfondo, inesorabile è il tramonto del “cantiere” che va verso la chiusura nel silenzio di gran parte della politica. Ma non tutto di quelle universali battaglie per la libertà e la dignità del lavoro sembra essersi perduto, se l’ultima immagine che ci restituisce l’autrice è quella di Vincenzina che va verso il suo piccolo Ferdinando «con una luce che piomba addosso come un prodigio». Una luce che forse è solo l’alba di un nuovo giorno per tutte le donne che come lei e le sue compagne di lavoro hanno combattuto a testa alta per un altro, possibile orizzonte umano e civile del nostro Paese.
1) F. Mastriani, Le ombre. Il romanzo sul lavoro femminile a Napoli nell’800, introduzione di Luca Torre, Napoli, Luca Torre, 1992, p. 5.
2) Ivi, p. XVIII.
3) Cfr. Le ombre, op. cit. p. 353.
4) A. Palermo, La letteratura (1860 – 1930), Storia di Napoli X, Napoli contemporanea, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane 1971, p. 515.
5) Carmine Castaldi, Dall’arte del legno all’ Alfa Sud e ritorno, prefazione Rocco Civitelli, Napoli, Iris Fontanelle, 2021, p. 18.
6) M. Severini, Fratture della memoria. Storia delle donne in Italia dal 1848 ai nostri giorni, Venezia, Marsilio Editore, 2023, p. 17.
7) G. Picone, «La scrittura come progetto di verità», intervista a Emma Giammatei, in «Il Mattino», Speciale Matilde Serao, 5 ottobre 2023.
8) M. Serao, Il ventre di Napoli, Bur Rizzoli, Napoli, 2012, p. 97.
9) M. Prisco, La città verticale. Napoli nella letteratura dagli ultimi decenni dell’Ottocento al nuovo millennio, Oedipus, Salerno, 2006, p. 31.
10) Sul rapporto tra teatro e letteratura, si veda Teatro e Letteratura: parole di scena, Perseo. La sfida del Teatro, Rivista semestrale del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, maggio 2023, anno III, n.1.
11) S. Zazzera, Dizionario napoletano. Il napoletano non è un dialetto. È una lingua, una musica, un modo di essere, Napoli, New Compton Editori, 2022, p. 7.
12) M. Marmo, Il proletariato industriale a Napoli in età liberale, Napoli, Guida, 1978, p. 135.
13) I. Sales, con la collaborazione di Marcello Ravveduto, Le strade della violenza, malviventi e bande di camorra a Napoli, Napoli, l’ancora del mediterraneo, 2006, p. 48.
14) P. Ricci, Le origini della camorra, Napoli, Edizioni Sintesi, 1989, pp. 108-109.
15) Il ventre di Napoli, op. cit., p. 43.
16) Edito per la prima volta nel 1944, rieditato da Einaudi nel 2010.
17) M. Stefanile, La letteratura tra il 1930 e il 1970, Napoli, Società Editrice Storia di Napoli, 1971, pp. 620-621.
18) A. Lezza, Introduzione in Raffaele Viviani, Poesie. Opera completa (a cura di Antonia Lezza), Napoli, Guida, 2010, p. 31.
19) Ibidem.
20) Il romanzo è stato recentemente ripubblicato in un numero limitato di copie col titolo Il Muratore della Sanità, a cura di Carlo Avilio e Caterina Tucci, postfazione di Antonio Caiafa, Global Print (Milano), 2023.
21) Cfr. D. Bernard, Realtà, potere e finzione. Vita e opere di Carlo Bernari, (in corso di pubblicazione).
22) Pubblicato in Lea Vergine, Napoli ‘25/’33, Napoli, Il Centro Edizioni, s.d. (ma, 1971); si veda anche la ristampa del volume, edito a Napoli da Clean nel 2018.
23) Cfr. F. Menna, Un normanno a Napoli, in Paolo Ricci. Opere dal 1926 al 1974, Museo Pignatelli, catalogo della mostra, electa Napoli, 1987.
24) V. Viviani, Storia del teatro napoletano, Napoli, Guida Editori, 1969, p. 911.
25) E. Rea, Mistero napoletano. Vita e passione di un comunista negli anni della guerra fredda, Torino, Einaudi, 1995, p. 79.
26) S. Cacciapuoti, Storia di un operaio napoletano, Roma, Editori Riuniti, p. 179.
27) Edito da Einaudi nel 1978.
28) E. Rea, Mistero napoletano, op. cit. p. 105.
29) Cfr. G. Galasso, Addio a Renato Cappa, fondò “Nord e Sud“, «Corriere del Mezzogiorno», 25 giugno 2006.
30) A. D’Ambrosio, Canzone per Nejra, tra guerra e terrorismo, Napoli, Colonnese Editore, 2005.
31) L. Rossomando, le fragili alleanze. Militanti politici e classi popolari a Napoli (1962 – 1976), Monitor, 2022
32) P. Roth, Pastorale americana, traduzione di Vincenzo Mantovani, Milano, Corriere della Sera, 2018, p.138.
33) F. Ramondino, Ci dicevano analfabeti. Il movimento dei disoccupati napoletani degli anni ’70, Postfazione di Enrico Pugliese, Lecce, Argo, 1998, p. 14.
34) O. Ottieri, Donnarumma all’assalto, Milano, Bompiani, 1959.
35) E. Ferrante, Storia di chi fugge e di chi resta, L’amica geniale, volume terzo, Roma, edizioni e/o, 2013, p. 106.
36) A. Tourrain, Critica della modernità, Milano, Il Saggiatore, 1993.
37) M. R. Selo, Vincenzina ora lo sa, Milano, Rizzoli, 2023, p. 12.
38) Ivi, pp. 71-72.



