Sul sentimento del sacro nel teatro di Antonio Neiwiller
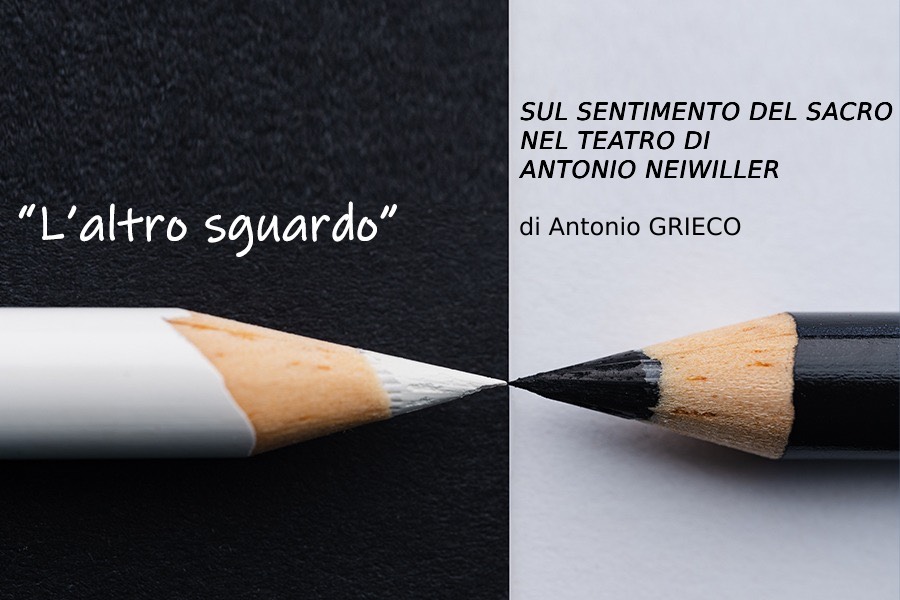
di Antonio GRIECO
Il teatro non è una merce
A trent’anni dalla scomparsa di Antonio Neiwiller – attore, autore, regista, artista visivo, avvenuta prematuramente il 9 novembre 1993 – una importante iniziativa – “un attraversamento fra musica, teatro, cinema” – è prevista alla Sala Assoli di Napoli (dal 19 al 22 ottobre) per ricordare il suo fondamentale contributo alla scena contemporanea italiana. Tuttavia, in questo anniversario – ricordato negli scorsi mesi anche a Milano e a Procida, dove tenne i suoi laboratori e mise in scena alcuni dei suoi originali lavori – è difficile analizzare la sua poliedrica figura di artista senza avvertire un senso di profonda amarezza per quella sorta di damnatio memoriae che in questi anni si è abbattuta con cieco furore su tante personalità “irregolari” del nostro teatro, che come lui hanno lottato per tutta la vita per un’arte libera, lontana da qualsiasi tentazione mercantile dell’esperienza creativa. Del resto, egli ci aveva messo in guardia per tempo da questa ormai sempre più allarmante alterazione della finalità del lavoro artistico in un testo, Per un teatro clandestino, dedicato a T. Kantor, che accompagnava L’altro sguardo (1993), il suo ultimo spettacolo: «È tempo, osservava, che l’arte esca dal tempo astratto del mercato…Bisogna usare tutti i mezzi possibili per trovare la morale profonda della propria arte. Il passato e il futuro non esistono nell’eterno presente del consumo». Neiwiller – e questo dobbiamo assolutamente ribadirlo per evitare che il suo ricordo si trasformi in un retorico e innocuo omaggio alla memoria -, dunque, era profondamente consapevole che in questo incomprensibile scenario postmoderno, dove tutto ormai sembra solo funzionale al profitto, fosse assolutamente necessario andare in un’altra direzione, mutare lo sguardo, testimoniare anche con la propria arte un’altra idea di mondo, recuperando anche in scena tutta la propria libertà e autonomia creativa: «il tempo in cui girano altri tempi e tu non puoi avere che il tuo tempo» (Antonio Neiwiller, Non ho tempo e serve tempo (L’Alfabeto Urbano,, 1988); una resistenza culturale, politica e artistica, insomma, che nel suo teatro si coniugava sempre ad un radicale rifiuto di quella sterile replica del reale che non permetteva di cogliere la profondità delle cose nell’oscuro vortice del divenire.
L’esperienza fondante del laboratorio
In tal senso, se proprio vogliamo sintetizzare in un’immagine la sua poetica, possiamo dire che il suo teatro aveva il dono di risvegliare sia negli attori che negli spettatori un laico “sentimento del sacro”; un’idea spirituale e “totalizzante” della messinscena, da vivere però sempre in simbiosi con qualcosa di concreto, di materiale, e per questo intimamente legato al nostro stesso vissuto. Per questi motivi, Neiwiller, oltre che straordinario sperimentatore di nuovi linguaggi espressivi – i suoi spettacoli si presentano quasi sempre frammentari, aritmici, “antirappresentativi“ – è stato maestro di vita per tanti giovani attori che guardavano (e fortunatamente continuano a guardare anche a distanza di anni dalla sua scomparsa) al suo teatro – aperto ad audaci contaminazioni con altre espressioni della creatività (pittura, poesia, cinema, danza e musica, soprattutto) – come ad una vitale esperienza umana che consentiva loro di riscattare una inaccettabile condizione di esclusione sociale. Così, nel tempo, egli non solo riuscì a rigenerare in Italia la figura dell’uomo di teatro interartistica, ma divenne un infaticabile costruttore di comunità tra arte e vita ai margini. Attraverso la fondamentale pratica di laboratorio («il laboratorio è per me il luogo della mente e del corpo dove si creano le condizioni vitali della ricerca» , Questioni di frontiera, testo per il laboratorio, 1987), negli anni Ottanta – nel periodo cioè più pervasivo della cultura neoliberista nella società contemporanea – egli seppe poi, in grande solitudine, trasferire alla sua giovane comunità di attori l’idea di un teatro come un insostituibile territorio dell’immaginario alternativo ai dogmi del pensiero unico che stava mettendo pericolose radici anche nel mondo dell’arte. Senza però mai separare, in nessun momento della propria ricerca, etica ed estetica, discorso sull’arte e meditazione sui devastanti processi economici e sociali in atto nel mondo: una costante interrogazione sull’orizzonte del presente che, a pensarci bene, si poteva già scorgere in filigrana negli anni Settanta quando col suo gruppo – prima Centro teatro Sud e poi Teatro dei Mutamenti (con Renato Carpentieri) – mette in scena lavori, come Don Fausto (1975) di Antonio Petito, Quanto costa il ferro? (1976) di Bertolt Brecht, Berlin Dada (1978) – che in una originale investigazione del rapporto tradizione-avanguardia, ci invitavano a non perdere mai di vista i nuovi, inquietanti, orizzonti della contemporaneità: basti pensare, ad esempio, proprio a Berlin Dada, uno spettacolo sull’avanguardia berlinese dei primi decenni dello scorso secolo, dove Franz – il protagonista dalla personalità contraddittoria del romanzo di Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz (1929) – sembra chiaramente evocare il senso di spaesamento di un’intera generazione che nell’Italia di quegli anni vedeva ormai svanire nel nulla i sogni di profondi, strutturali cambiamenti della società borghese da cui proveniva; un processo di evidente arretramento culturale oltre che politico, che spinse alcuni suoi compagni di viaggio ad abbandonare il lavoro di gruppo che sino ad allora aveva contraddistinto la propria ricerca teatrale.
La sconvolgente metafora del Titanic
Neiwiller, soprattutto dopo aver visto La classe morta di Tadeusz Kantor – e quasi a ridosso del tragico sisma che nel 1980 devastò Napoli e la Campania – decide invece di resistere, di rifondare la sua scena (con la sua nuova formazione del Teatro dei Mutamenti) ripartendo da zero, da una nuova comunità di attori non professionisti e dalla pratica interdisciplinare del laboratorio. Nasce, così, Titanic the end (1983), tratto dal poema di Hans Magnus Enzensberger La fine del Titanic: un teatro di naufraghi, di fantasmi della memoria che attraversano la scena come “resti”: “scarti sociali” che, per dirla con Pasolini, non erano mai riusciti a stare al passo con la Storia. È forse il momento più intensamente visionario della sua nuova drammaturgia. Perché quei passeggeri di terza classe – interpretati splendidamente dai suoi giovani attori – che avevano perso per primi la vita nell’affondamento dell’”indistruttibile” transatlantico continuano ancora oggi ad interrogarci su quella falsa Modernità che da decenni trascina con sé, negli abissi del Mediterraneo, corpi di bambini, di donne e di uomini innocenti, che fuggono da terre martoriate nel generale cinismo delle nostre classi dirigenti. Naturalmente, siamo nel 1983 – dunque tra i finti bagliori della più violenta restaurazione culturale del nostro Paese dal Dopoguerra – e quel suo angoscioso grido d’allarme sulle “magnifiche sorti e progressive dell’umanità” cadde tristemente quasi nel vuoto: e furono anche in pochi ad accorgersi del valore simbolico dei silenziosi, fantasmatici gesti degli attori in scena. Che alla fine, quasi abbandonando ogni finzione, sembravano interpretare semplicemente se stessi, mostrando tutta la propria fragilità esistenziale che li condannava ad un ineluttabile destino di precarietà. Allo stesso modo, illuminanti (sull’alienazione del “Moderno”) furono spettacoli come Anemic Cinéma (1979), Black out (1982), Una sola moltitudine, del 1989, ispirato alla labirintica poetica di Ferdinando Pessoa.
L’altro sguardo e il senso del sacro
Ma dicevamo della sacralità di certe sue scene sospese in un’altra dimensione dello spazio e del tempo. Un laico sentimento del “sacro” che affiora nel suo teatro con più evidenza soprattutto quando inizia ad approfondire l’arte e il pensiero teorico di Paul Klee, con l’intenzione di trasferire a teatro tutta la spiritualità del suo universo pittorico e di trasformare lo spazio teatrale in uno spazio essenzialmente poetico irradiato dalla luce e dai corpi degli attori; nascono così, all’interno del Progetto Paul Klee (1986), due spettacoli: Fantasmi del mattino (1986) e Storia Naturale Infinita (1987): e un piccolo, aforistico libro dal fascino misterioso, Non ho tempo e serve tempo (edito, nel 1988, da Alfabeto Urbano). Tutta l’investigazione kleeniana di Neiwiller – compresi i suoi dipinti di quel periodo (che per Claudio Meldolesi rinviavano “al Klee irridente verso il distinzionismo svizzero ma senza rimuovere l’eccesso di materia depositata dal vicolo”) e la sua intensa attività laboratoriale (con l’impegnativo e rigoroso lavoro sull’Improvvisazione) – è, oltre a una intelligente riflessione sui codici stessi della rappresentazione (“il teatro che interroga se stesso”), meditazione sulla nudità dell’Essere, sulla sacralità della vita, sugli incerti confini tra il visibile e l’invisibile, tra il reale e l’immaginario; e, soprattutto, è radicale, lungimirante critica a quell’ inaccettabile antropocentrismo del nostro mondo costruito sull’idea che l’uomo sia il centro e il fine ultimo dell’universo. Ora, per il tramite di un intenso lavoro di decostruzione etico-linguistica (incrociando la lezione di Kantor con quella di Grotovski), la sua drammaturgia povera, essenziale, intensamente lirica, finirà sempre più per assumere la trasparenza e la leggerezza di un verso, l’elementarità di un segno. È “l’altro sguardo di Neiwiller”, un “teatro di frontiera” – lontano da «rapporti che si sono consolidati, strutturati, irrigiditi» – che vive solo di sguardi, di immobilità, di silenzi; uno spazio fisico e mentale, sospeso sulla soglia dell’Essere, che ci consente di scoprire quell’’’Altro assoluto” che – per Jaques Lacan – si nasconde nel nostro inconscio e fonda la nostra stessa soggettività. Neiwiller commenterà in Appendice per un laboratorio cinematografico, un breve testo del 1991, probabilmente scritto dopo aver notato per anni la inarrestabile deriva “produttivistica” del teatro contemporaneo: «Non ci renderemo mai conto abbastanza profondamente di quanto un sistema produttivo possa essere estraneo alle finalità di un lavoro artistico». Da qui, anche da questa angosciata meditazione sull’arte che verrà, prenderà l’abbrivio, come dicevamo, una drammaturgia “anti-spettacolare” percorsa in ogni istante da immagini e azioni incontaminate e liberatorie. E dal silenzio. «Perché il silenzio – dirà in una delle sue ultime interviste – è fondante ed è ciò che ti fa sentire il tempo e dà peso alle cose». Ma oltre questo spazio cosmico dell’Assenza e del Vuoto – come in Fantasmi del mattino (1985) – alla fine gli spettatori, nel buio, colti di sorpresa da un cielo improvvisamente stellato, avranno la felice sensazione di essere essi stessi parte di un magico incantesimo notturno. Questo radicale processo di “interiorizzazione e decolonizzazione dello sguardo” sarà, per tutti gli anni Ottanta, la cifra inconfondibile del suo teatro e del suo pensiero teorico (espresso, tra l’altro, con grande lucidità in Questioni di frontiera, un fondamentale testo, del 1987, sul rapporto tra arte, teatro e vita): anche dopo la fondazione di Teatri Uniti, il gruppo nato a Napoli nel 1987 dall’unione del suo Teatro dei Mutamenti con Falso Movimento e Teatro studio di Caserta, due vivaci gruppi d’avanguardia guidati rispettivamente da Mario Martone e da Toni Servillo. La ritroveremo ancora, questa laica “sacralità” neiwilleriana, come amara riflessione sul rapporto tra l’uomo e la natura, nel prologo di quell’uomo cieco (da lui stesso interpretato) che ne La natura non indifferente (1989) – uno spettacolo dedicato a Joseph Beuys, grande maestro dell’Arte Povera, fonte di ispirazione anche per diversi suoi laboratori in Italia e all’estero – guarda con lo stesso amore al vivente umano e non umano: «Vorrei unire gli uomini/ agli animali/alle piante/alla materia/ ma anche agli angeli/agli spiriti/ e questo sforzo/ possa diventare arte/ in un mondo che ai poveri toglie il pane/ e ai poeti la pace»; oppure, in quegli uomini e in quelle donne che in Dritto all’inferno (1991) – un lavoro su Pasolini parte del Progetto Trilogia della vita inquieta (dedicato, oltre che al poeta friulano, anche a Vladimir Majakovskij e Andrej Tarkovskij) che non riuscirà purtroppo ad ultimare –, percorrono la scena indossando lacere coperte; o, ancora, in quella attrice che ne L’altro sguardo (1993) – suo ultimo lavoro (di cui la filmmaker Rossella Ragazzi riprese magistralmente il suo struggente “Monologo”) con la partecipazione attoriale e la collaborazione di due artisti attori come Loredana Putignani e Giancarlo Savino – attraversa “solenne” una stanza semibuia con una candela spenta, avvicinandosi lentamente agli spettatori e aspettando che qualcuno tra loro la accenda. Neiwiller è stato un grande “rivoluzionario dello sguardo” che ci ha insegnato a “vedere” quando altri erano muti e ciechi. Ed anche un’azione semplice e simbolica come questa, che allude ad un cammino di speranza da condividere con l’Altro, crediamo possa ancora aiutarci – anche tra le macerie, anche a teatro – a riscoprire con il senso più vero della nostra esistenza “il tempo umano dell’espressione necessaria”. In fondo, “l’inattualità” di Neiwiller – che ancora oggi ce lo fa ricordare come un vivo e necessario “clandestino” dell’arte e del teatro – è tutta qui: in quel suo gesto “umano e sacro” incompatibile con un’idea produttivistica dell’agire creativo, tantomeno con un mondo della cultura sempre più pago di sé, sempre più disponibile, salvo rare ed encomiabili eccezioni, ad accettare, anche a teatro, i tempi e le regole imposti dal Potere costituito.



