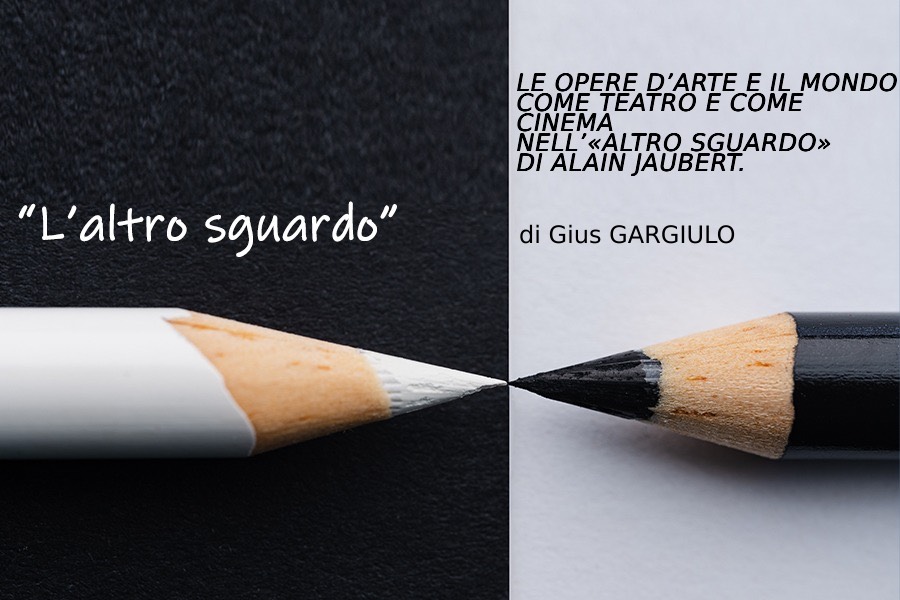Viviani e la tradizione. Una recensione per La festa di Montevergine

Il Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo in collaborazione con il Teatro Sannazaro (direzione artistica di Lara Sansone) ha ideato e promosso il progetto Viviani e la tradizione. Una recensione per La festa di Montevergine.
Quattro spettatori, tra studenti e appassionati della drammaturgia di Viviani, sono stati ospiti del Teatro Sannazaro per La festa di Montevergine, spettacolo in tre atti con musiche di Raffaele Viviani, regia di Lara Sansone.
Di seguito le recensioni dei partecipanti al progetto .
Viviani e la tradizione. Una recensione per La festa di Montevergine.
“Simme jute e simme venute,
quanta grazia c’avimme avute”
Così intonano i pellegrini oggi come ieri, che vanno a trovare la Mamma Schiavona nella sua cappella durante la Festa di Montevergine. Ci si va due volte all’anno, il 2 febbraio per la Candelora e il 12 settembre per la juta, cioè la salita del Montagnone, ad aprire e chiudere le celebrazioni per le Sette Sorelle, rituali cattolico-pagani dedicati alla Madonna. Ma qui, nella commedia di Viviani, La festa di Montevergine, messa in scena da Lara Sansone, siamo a maggio, fuori dal periodo della festa. ’O sanguettaro, ’a maesta, ’o vrennaiulo, ’a farenara, don Rafele attunaro e sua moglie donna Vincenza, mettono in scena il loro piccolo dramma fatto di amori non dichiarati e non dichiarabili, tra canti, pranzi, vestiti e pellegrini nella sontuosa cornice della festa di Montevergine, dove si incrociano rituali collettivi e storie private, ma di cui queste ultime non possono fare a meno delle prime per esibirsi. Il palco è decorato con una luminaria che ci ricorda il clima di festa; ad aprire le danze un cieco che elemosina un soldo ad un passante, dicendogli che prima gli aveva dato troppo poco. Dopo qualche minuto, entra in scena uno storpio, che canzona il cieco, dicendogli di spostarsi e farsi da parte, perché «’o pezzente nun ‘o sape fa’! E ’o pezzente, s’adda sape’ fa’!». Subito dopo torna in scena il passante che ha dato quel soldo al cieco: ’o vrennaiulo, ’O sanguettaro e ’a maesta sono partiti da Napoli tutti ‘ngannaccati (vestiti a festa) più per fare una gita fuori porta ed esibire i loro abiti migliori che per far visita alla Vergine. Nella piazza adiacente al Santuario si svolge il dramma tragico-comico della gelosia tra due coppie piccolo borghesi, provocato ed alleggerito per tutta la messa in scena dalle battute sagaci della maesta, splendidamente interpretata da Lara Sansone, anche regista della pièce, che dietro un dichiarato finto intento di riservatezza, scoperchia il vaso di Pandora della relazione clandestina, dando vita ad un incrocio di anime, che si concluderà bonariamente in stile commedia. Questa a grandi linee, la trama della commedia, La festa di Montevergine, che Raffaele Viviani scrisse nel 1928.
Ma concentriamoci per un attimo sulla festa e sui personaggi che fanno da vivace cornice alla vita dei protagonisti.
È nel racconto dei pellegrini, nei suoni e nei canti ’a ffigliola, che Viviani racconta del popolo, delle sue miserie e delle sue feste, per rappresentare un mondo che conosceva bene, nel profondo della sua umanità.
Non è un caso che la pièce s’intitoli La festa di Montevergine, con il doppio intento di alludere alla festa vera e propria e a ciò che può accadere nelle vite private degli esseri umani, durante la festa. Si intrecciano celebrazioni collettive, vita pubblica e privata, in una messa in scena umana di cui è difficile definire i contorni.
E probabilmente è proprio questo l’intento di Viviani autore, quello di non definire confini tra ciò che accade nelle nostre vite e le strade, i bassi e le piazze in cui esse si consumano, in una performance collettiva tra autore, pubblico e attori.
Ma il mondo che conosceva Viviani è cambiato, a quasi cento anni di distanza dalla scrittura di questa commedia, la realtà non è più la stessa.
Come mettere in scena allora, oggi, un testo come La festa di Montevergine?
Rispettandone testo e intenti, così come avrebbe fatto il suo autore o rileggendolo ex novo?
In questo il rapporto con la tradizione è complesso e conduce su un terreno scivoloso.
E in questa riproposizione del testo, la regista e attrice Lara Sansone decide di rimanere nel primo campo di azione in tutte le scelte stilistiche della mise en scène, a partire dalla scenografia, che ci ripropone figurativamente piazze, taverne e cappella della Mamma Schiavona, ai costumi, alla recitazione ammiccante degli attori che cercano una relazione con il pubblico, cercando di abbattere la distanza tra loro e la scena, favoriti anche dall’adattamento della platea in una sala d’osteria informale seduti a dei tavolacci a mangiare e sorseggiare tarallucci e vino.
Ricordando le parole di un altro grande autore contemporaneo, Enzo Moscato, sull’etimologia e il significato della parola tradizione, il drammaturgo ci insegna che tradizione, viene dal latino traděre, che significa sì trasmettere, ma anche tradire.
Moscato va all’origine della parola, creando però da essa anche lui un neologismo, che è quello della tradinvenzione, problematizzando così il rapporto tra la tradizione e la riscrittura affermando che il tradimento è una categoria fondamentale dell’arte.
Quindi la tradizione non è solo ripetere pedissequamente qualcosa di conosciuto, nelle forme canoniche in cui ci è stato tramandato (questo non sarebbe comunque possibile, perché tutto è un divenire), ma soprattutto un tradimento necessario verso quelle forme, affinché continuino ad esistere in vita.
Un concetto potente quello della tradinvenzione, in cui risiede però l’atto creativo, fenomeno valido non solo per la scrittura, ma per tutta la messa in scena di una pièce.
Il confronto con la tradizionale Festa di Montevergine è reso ancora più complesso dal fatto che essa è depositaria di ambientazioni, immaginari e simboli di profondo radicamento culturale.
Un altro grande drammaturgo napoletano Annibale Ruccello, conterraneo di Viviani, negli anni Settanta aveva iniziato una vera e propria ricerca antropologica sulla festa e sulle tradizioni popolari.
Lo aveva fatto come antropologo occupandosi della Cantata dei Pastori.
Giovanna Marrazzo
La Festa di Montevergine
La Festa di Montevergine, una vera celebrazione che unisce sacro e profano, un lavoro nel quale Viviani fonde il rito della devozione popolare alla Madonna, con il profano dei contrasti umani, dettati dai tradimenti e dalle gelosie, che favoriscono il mormorio e il pettegolezzo.
Al Sannazaro questo capolavoro viene riprodotto in modo sorprendente, tanto da unire la tradizione popolare all’originalità. Il Teatro, infatti, si trasforma grazie ad una grande scenografia e il pubblico sembra trasformarsi, gradualmente, in un gruppo vivo e allegro di figuranti dell’intera compagnia. Gli spazi sono gestiti dagli Attori in modo perfetto, quasi da sembrare concordati con gli spettatori che, al loro ingresso, hanno trovato, al posto delle consuete poltrone allineate della platea, un insieme di tavoli stretti e lunghi che ripropongono la piazza e i tipici punti di ristoro per i pellegrini in viaggio. Nei naturali corridoi delle tavolate, inizia l’Opera, con il corteo che apre l’immaginaria salita al monte dei devoti, tra canti e invocazioni alla Madonna.
In questo contesto del tutto naturale e vivo, le prime tracce significative sono segnate da tre cavalli, energicamente interpretati da giovani Artisti, che riescono con grande maestria a non sfiorare minimamente i più vicini spettatori, fino a sfoggiare tutta la loro furia sui tavoli, saltando e cantando con la leggerezza tipica dei puledri. In crescendo sale la meraviglia per l’ingresso in sala di un vero asino cavalcato da un pellegrino, che sancisce la definitiva familiarità tra il pubblico e l’intero Cast.
Prende corpo il lavoro attraverso la rappresentazione di un mondo parallelo, da un lato fatto di canti, danze e ringraziamenti alla Madonna, dall’altro fatto di mormorii su una evidente tresca amorosa, che alimenta la discordia tra i pretendenti, fino alla lite.
La finzione e la realtà continuano ad intrecciarsi persino durante l’intervallo, che diventa un tutt’uno con il lavoro e permette al pubblico di vivere effettivamente il momento di pausa del pellegrinaggio, con bicchieri di vino e taralli tipici della festa, offerti ai presenti, in attesa di riprende il “cammino”.
In questo susseguirsi di movimenti e scene, spicca la personalità di Lara Sansone che onora in modo egregio l’eredità artistica trasmessale dalla nonna Luisa Conte, attraverso una presenza scenica spontanea e naturale, che ha dato vita ad una tipica personalità popolare, mettendo in risalto il proprio temperamento artistico.
La scelta, infatti, di modulare la voce su alcune particolari battute, con una specifica mimica facciale, ha arricchito di espressività alcuni suoi interventi e ha evidenziato, ancor più, la peculiarità del personaggio che non disdegna il pettegolezzo.
A Lara Sansone va riconosciuto, inoltre, il merito di aver indossato, altrettanto egregiamente, anche le vesti da Regista, attraverso la gestione di una compagnia di comprimari, alcuni dei quali già veterani, tutti di talento. Ognuno di loro ha saputo caratterizzare il personaggio dando rilevanza alla coralità del lavoro, grazie soprattutto ad una perfetta gestione dei ritmi nelle battute, che in modo coerente alla vivacità delle azioni, ha permesso al pubblico di assistere alle tipiche scene paradossali, in modo palesemente divertito.
Di fatto, la corposità di questo lavoro consente a tutti gli Artisti di esprimersi al meglio, dalla recitazione al ballo e per alcuni anche nel canto, dove emergono particolari timbri vocali, sia maschili che femminili.
Lo spessore di un Capolavoro del genere, firmato Raffaele Viviani, risulta convalidato dall’affluenza di pubblico che, anche in questa stagione, ha riempito il Teatro Sannazzaro e che, in particolare, alla Prima ha visto seduti nella “piazza”, come spettatori, Artisti di rilievo come Isa Danieli, Peppe Barra, Geppy Gleijeses e Nina Sodano.
Non resta che augurare che la Festa di Montevergine ritorni ancora per molto tempo in scena al Teatro Sannazaro, con lo stesso spirito e la stessa energia, nella certezza di ricevere in cambio, ancora tante volte, il meritatissimo prolungato applauso del “devoto” pubblico.
Maria Mauro
“LA FESTA DI MONTEVERGINE” RITORNA AL TEATRO SANNAZARO CON LA REGIA DI LARA SANSONE: QUANDO IL CORAGGIO VIENE ANCORA UNA VOLTA PREMIATO
Coraggio. È quello che di questi tempi ci vuole: coraggio di osare. Lara Sansone e la Compagnia del Teatro Sannazaro hanno sicuramente avuto ancora una volta coraggio nel mettere in scena un testo di Raffaele Viviani, soprattutto in un periodo in cui le sale cittadine pullulano di messe in scena sperimentali, “povere” (come direbbe Grotowski). A quasi 100 anni dalla sua prima messa in scena (6 Gennaio 1928 a Napoli, ma testo scritto nel 1912), al Teatro Sannazaro va in scena La Festa di Montevergine per la regia, appunto di Lara Sansone. Uno spettacolo dal grandioso allestimento, se si considera una compagnia composta da ben 38 personaggi.
La trama riporta una commistione tra sacro e profano: sullo sfondo del pellegrinaggio alla Madonna di Montevergine si staglia una storia di amori e tradimenti. Nel primo atto, ambientato appunto in cima al Monte Partenio, all’esterno del Santuario, tra i numerosi fedeli che giungono a piedi da tutto il Sud Italia per rendere grazia a Mamma Schiavona in una processione cantata e appassionatamente evocativa, fanno capolino tre coppie provenienti da Napoli: ’o sanguettaro (un comicissimo Lucio Pierri) e ’a maesta (interpretata superbamente da Lara Sansone, nel ruolo che fu della nonna Luisa Conte e prima ancora di Luisella Viviani), i quali si trovano a fare quasi da “pacieri” tra le altre due coppie, composte da o’ vrennaiuolo (un intenso Ciro Capano) e ’a farenara (a cui dà il volto Ingrid Sansone che dà ancora una volta prova della sua bravura) la quale ha una relazione clandestina con don Rafele attunaro (l’attore di esperienza Gennaro Di Biase che interpreta proprio il ruolo che fu di Raffaele Viviani) sposato con Donna Vicenza (la brava Ivana Maione). Le tre coppie, nel secondo atto, si ritroveranno a Nola, sulla via del ritorno, nell’osteria di Pappone (Salvatore Misticone che caratterizza a dovere il personaggio regalando numerosi attimi di comicità) in un clima tutt’altro che sereno; sarà poi un elemento sacro (“il canto ‘a ffigliole”, così chiamato perché al canto solista rispondeva un coro la cui espressione era appunto «Ffigliole, ffigliole») a rovesciare gli equilibri “profani” e svelare la relazione adulterina tra ’a farenara e Don Rafele.
Lara Sansone sceglie ancora una volta (così come aveva fatto per Festa di Piedigrotta, altro lavoro corale di Viviani) di far immergere totalmente il pubblico nell’atmosfera festosa che caratterizza poi l’intero spettacolo: le poltrone della platea sono sostitute da lunghi tavoli e da panche da osteria, sui quali, tra il primo e il secondo atto, sono offerti vino e taralli napoletani; sullo sfondo le luminarie e una pioggia di coriandoli che cala dall’alto. L’accurata regia – della stessa Lara Sansone – ha messo molto bene in risalto quello che Giulio Trevisani, commentando proprio questo testo, definì il «panorama di varia umanità napoletana e popolare» raffigurato qui dai suoi maggiori rappresentanti: ’o castagnaro, ’o maccarunaro, ’o turrunaro, ’o caffettiere, ’o tiro a tre, ’o ciucciaro, tutti esponenti del teatro del vero firmato da Viviani.
Un lavoro corale, dunque, che richiede – come in tutti i lavori di Viviani – un cast “poliedrico”: non basta saper recitare ma bisogna avere anche doti canore e coreutiche. Tutti gli attori di Festa di Montevergine, dai protagonisti a Mario Aterrano (anche assistente alla regia), a Tina Scatola (doppio ruolo anche per lei), a Gino Curcione e a tutti gli altri, si sono dimostrati all’altezza della complessità che il testo richiedeva. Degna di nota la scena dell’ingresso dei fedeli all’interno del Santuario, resa ancora più evocativa da una quinta girevole (realizzata da Retroscena srl) e da un gioco di luci (curate da Luigi Della Monica), elementi che hanno coinvolto gli spettatori, come se si trovassero anch’essi all’interno del luogo sacro.
Non è la prima volta che la Compagnia del Sannazaro propone questo testo: in scena già nel 2014 per celebrare i 20 anni dalla scomparsa di Luisa Conte, la quale aveva riportato, insieme al marito Nino Veglia, agli antichi splendori proprio la “bomboniera” di Via Chiaia. E anche in quell’occasione lo spettacolo fu un successo. Grazie ad una buona e sapiente regia e ad un ottimo cast, Viviani è ancora tremendamente attuale ed è ancora fonte di riconoscimento per il pubblico. Un coraggio, quello di Lara Sansone e dei suoi, decisamente premiato a pieni voti.
Francesco Pace
La celebrazione della tradizione popolare tra sacro e profano
Ritorna in scena, a grande richiesta, lo spettacolo “La festa di Montevergine” di Raffaele Viviani per la regia di Lara Sansone, nella suggestiva cornice del Teatro Sannazaro. Fin da subito, la platea e il palco si fondono in un’unica grande festa, la rottura della quarta parete è immediata e coinvolgente. Il profumo di incenso, le luminarie, gli stendardi della Madonna sui palchetti, le panche, il vino, i taralli e i balli rendono la Festa di Montevergine uno «spettacolo corale, capace di fondere sacro e profano», come si afferma nel programma di sala, attraverso le parole della stessa Sansone. Il sacro del Santuario e il respiro della sacralità che si percepisce attraverso la salita al monte, sono elementi trasmessi al pubblico attraverso la “fatica”: i pellegrini vengono in processione dalle Puglie, dalla Basilicata e dal Molise, portando fino all’ingresso del Santuario, in platea e in proscenio, un mulo vero, accompagnato da ’O ciucciaro.
Una festa in cui si incontrano, chiacchierano e “inciuciano” i fedeli devoti della Madonna: ’O sanguettaro (Lucio Pierri), ’A maesta (Lara Sansone) ’O vrennaiuolo (Ciro Capano), ’A farenara (Ingrid Sansone), Don Rafele attunaro (Gennaro di Biase) e Donna Vincenza (Ivana Maione) danno vita e voce alle parole cariche di ironia, comicità e cultura popolare di Raffaele Viviani. Gli attori in scena sono 38, in aggiunta al coro dei fedeli; le vicende dei protagonisti si fondono con le tammurriate e i canti a fronna ’e limone, in una sfida canora che genera continui applausi di incitamento del pubblico per sostenere le paranze nel loro duello. Le musiche di Viviani sono state elaborate da Paolo Rescigno Studio 52 e interpretate da ‘O turrunaro (Enzo Tammurriello), dalla voce solista di Marisa Portolano e dal coro dei fedeli. I cambi di scena sono stati inglobati minuziosamente nello spettacolo grazie ad una perfetta sinergia tra musica e luci (disegno luci di Luigi Della Monica).
Commedia in tre atti, scritta nel 1928, proietta gli spettatori in un’opera senza tempo nel Tempio di Cibele, della grande madre, la Mamma Schiavona protettrice dei “femminielli”. Ancora una volta il sacro e il profano si intrecciano, si mescolano e si contagiano nei dialoghi serrati e nelle interpretazioni dei personaggi di Viviani che trasudano una comicità e una religiosità emozionante e travolgente.
Da apprezzare la fedeltà della regista nel rispettare il napoletano arcaico, inserendo nel programma di sala la traduzione di alcune parole utilizzate nella commedia come: ’O sanguettaro (l’esperto dell’applicazione di sanguisughe, il più delle volte un barbiere), ’O canto ‘a ffigliole (canto di origine popolare, è un canto di festa) e ’O Vrennaiuolo (il venditore di biada e crusca). Una lingua che possiede il dono di mettere in risalto la cultura e la tradizione di un popolo in una continua danza tra parole e gestualità del corpo teatrale.
Sono passati oltre settant’anni dalla morte di Raffaele Viviani, ma le sue opere e le sue musiche rappresentano per il teatro napoletano un pilastro culturale e popolare inamovibile, capace ancora di emozionare e far divertire. Nei calorosi applausi finali della messa in scena non poteva mancare un omaggio al terzo scudetto del Napoli: l’energia del palco e degli attori si è fusa con la platea in un unico grande coro.
Uno spettacolo da vedere e rivedere.
Gianpiero Petraroli