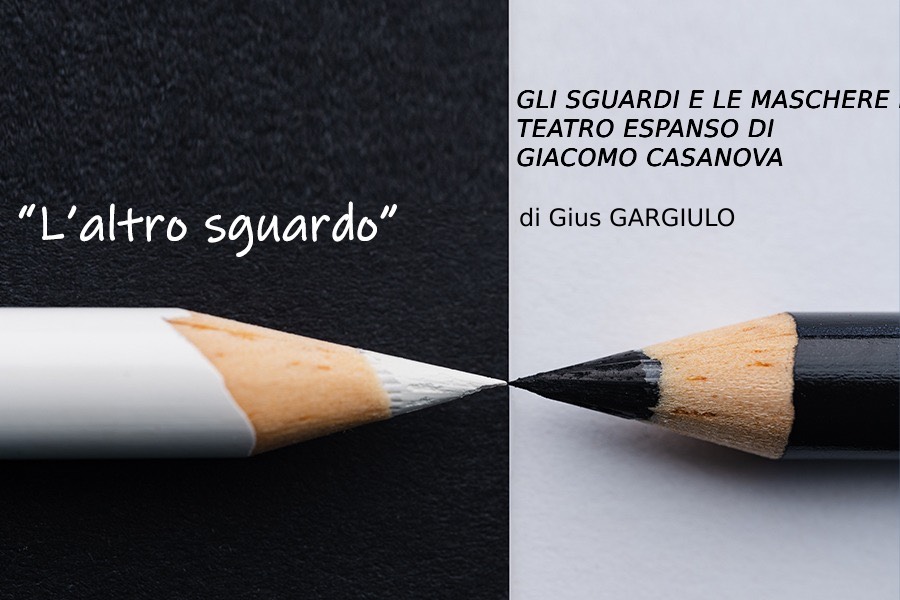“Il treno dei bambini” di Viola Ardone. Contributi dei relatori

Di seguito i contributi di Mario Di Giovanni, Federica Caiazzo e Rosa Troiano relativi alla presentazione del volume “Il treno dei bambini” di Viola Ardone.
Buonasera e bentrovate/i tutte/i. Mi associo al ringraziamento della prof. Antonia Lezza rivolto in primis ai membri dell’Associazione Centro Studi sul Teatro napoletano, meridionale ed europeo, nella cui sede siamo ospitati con generosità e garbo, e poi alle tante persone amiche che affollano quest’aula nonché a chi partecipa magari solo per ‘curiosità’ a quest’evento di presentazione del romanzo di Viola Ardone qui accanto a me, Il treno dei bambini.
Siedono di fronte a voi persone attrezzatissime per dialogare, dopo il mio intervento, con l’Autrice su aspetti specifici dell’opera, la cui scrittura è davvero magica, priva di retorica eppure capace di far spuntare le lacrime mentre sorridi; io invece mi propongo di sottoporvi in modo succinto una questione introduttiva di carattere generale.
Il libro di Viola è una storia, una gran bella storia.
Ovviamente lo sono pure molti altri romanzi che campeggiano nelle librerie perché noi da sempre siamo affascinati dalle storie che non ci stanchiamo di ascoltare fin da piccoli, per poi raccontarle o scriverle perché altri le ascoltino o le leggano e provino intense emozioni.
Penso, e vi invito a fare mente locale, ai racconti fondanti della nostra civiltà, quelli della Genesi, per esempio, in apertura della Bibbia. Ricordate quell’incantevole racconto della Creazione svolto da Mosè, il grande affabulatore, al suo popolo fuggitivo dalla schiavitù dell’Egitto (di cui rimpiangeva le cipolle!), accasato precariamente nel deserto, che ascolta rapito i dettagli della nascita del cielo e della terra seguendo con lo sguardo il suo dito che mostra le stelle e ogni essere vivente. Ciò è evocato nel famoso dito di Dio che, come immagina Michelangelo, crea Adamo sfiorando la sua mano.
Ma forse vi è più familiare un altro racconto, quello di Omero in quel vero e proprio protoromanzo che è l’Odissea, cantato con la cetra e solo più tardi, come successe per la Genesi, messo per iscritto.
Dov’è il segreto di questi successi? La bravura di chi narra che parlando o cantando procura emozioni che ci pervadono e catturano di conseguenza il nostro cervello: in altre parole non c’è storia, non c’è narrazione se manca qualcuno che parlando o scrivendo te la racconti e ti tocchi il cuore, e solo per questa strada il messaggio passa poi nel nostro intelletto in modo luminoso e si fissa nei ricordi.
È questa la bravura, quando c’è, ancora oggi di chi scrive o recita, e bene lo sanno gli amici di questo Centro Studi che si occupa di teatro in molti modi diversi.
Allora, riprendendo il nostro filo, assodato che il romanzo in questione è una storia, occorre poi precisare che esso si colloca in un crinale interessantissimo, tra Storia e Microstoria.
Nel secolo scorso in Francia M. Bloch e L. Febvre fondarono la scuola de Les Annales, a cui si aggiunsero F. Braudel e J. Le Goff. Lo scopo era di ampliare e arricchire l’orizzonte classico della storia, gli Eventi, i ‘macro avvenimenti’ (grandi leader, epiche battaglie, magistrali trattati di pace, etc.) con i ‘micro vissuti’ della vita quotidiana di uomini e di donne nel tempo e nello spazio.
Quindi siamo passati dalla Storia alle Storie, utilizzando allo scopo le scienze sociali come l’economia, la demografia, la cartografia, la psicologia, etc. Di qui l’ormai consolidata distinzione tra macrostoria e microstoria. Faccio per ovvi motivi solo un cenno alla questione che, per chi volesse saperne di più, si può ritrovare esposta in modo magistrale in Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico e anche in L. Canfora, Prima lezione di storia greca.
Infatti, la prof. Ardone, avendo sullo sfondo la più grande tragedia umana della storia, la seconda guerra mondiale, inserisce in essa magistralmente le storie di bambini napoletani, e di uno in particolare Amerigo, che vivono nel gravissimo disagio economico e sociale del dopo guerra, tanto da indurre i loro genitori ad affidarli a famiglie contadine del Nord Italia, in particolare emiliane e modenesi, che con generosità nelle loro case ne avranno cura (mantenimento, istruzione, etc.) per periodi di tempo più o meno lungo.
Mi si consenta una parentesi. Immagino che la parola storia abbia fatto emergere in qualcuno di voi insopportabili fantasmi del passato scolastico, gli assegni perentori dopo una noiosa lezione, “studiate da p. 132 a p. 169”. Proviamo a rimuoverli ricordando l’etimologia della parola ‘storia’, essa viene dal greco ἱστορία che è ricerca fatta da qualcuno che poi te la racconta facendotela vedere (Ἱστορ condivide la stessa radice del perfetto oîda, conoscere, legato a sua volta alla nozione del vedere). Capisco l’obiezione, ma quanti docenti di storia riescono a fare questi passaggi dal cuore alla mente e agli occhi così che anche l’alunno possa dire come l’interlocutore di Socrate nel celebre mito della caverna: “Sì, lo vedo”? Eppure qualcuno c’è come è capitato alla prima donna a dirigere il CERN e ad essere confermata dopo il primo mandato, parlo di Fabiola Gianotti che nel liceo classico delle Orsoline a Milano è fascinata dalla sua insegnante di Scienze, o ad Alessandro Stanziani, allievo dello scientifico napoletano “T. L. Caro” destinato forse a fare l’ingegnere, ma anche lui ‘catturato’ dal docente di storia tanto che oggi occupa a Parigi la cattedra che fu di Braudel da me or ora citato.
Chiusa la parentesi, torniamo al romanzo di Viola che ha, come dicevo, sullo sfondo gli eventi della guerra, pensate che solo a Napoli si registrano 105 bombardamenti con 22 mila morti e immani distruzioni. Questo lo ‘vediamo’ attraverso gli occhi di Amerigo e le tante microstorie di bambini napoletani provati, immiseriti, deprivati anche dell’indispensabile per sopravvivere, a volte orfani o con un solo genitore, nei cui confronti si manifesta la solidarietà di altri italiani, quelli del Nord.
Vengono così organizzati i viaggi in treno di ben 70.000 bambini dal Sud verso l’Emilia in particolare, ma anche verso la Toscana o l’Umbria, tra il 1946 e il 1952; essi furono salvati dalla fame, dall’analfabetismo e dalle malattie, grazie allo sforzo e alla solidarietà di donne e uomini, che iniziarono con lungimiranza a sognare una nuova Italia. Perciò la nascita dei “Comitati per la salvezza dei bambini” rappresenta un esempio di sostegno disinteressato e organizzato che unì Nord e Sud, più fortunati e poveri, nello sforzo di sostenere l’infanzia, cioè il futuro.
Coordinati dal Partito Comunista Italiano e grazie al lavoro di donne di valore che fanno politica attivamente dopo aver dato una mano anche nelle famose Quattro Giornate (ricordate Lenuccia che salva il Ponte della Sanità dalla barbarie nazista? Ebbene qui la ritrovate alla grande), i bambini furono trasferiti con i cosiddetti ‘treni della felicità’ da Napoli in particolare, come dicevo, presso famiglie contadine settentrionali. Queste ultime, pur provate anch’esse dalla guerra, si mobilitano con spirito solidale di cui abbiamo nostalgia, per proteggere i piccoli: che lezione per noi oggi chiusi spesso nell’egoismo, ‘incattivi’, pronti solo a infangare, a offendere, a oltraggiare.
Di queste storie cresce piano piano la conoscenza. Un buon manuale di storia oggi, ma solo oggi, accenna a questi aiuti tra la nostra gente, dandone conto in poche righe; questo succede perché questa microstoria è stata svelata anche, in anni a noi più vicini, da G. Rinaldi che pubblica nel 2008 un libro per documentarla, I treni della felicità, dopo aver prima con il regista A. Piva riscoperto e ricostruito le vicende dei bambini con puntualità attraverso le testimonianze raccolte appunto nel film-documentario Pasta nera, la cui genesi è narrata nel libro citato.
Ancora, mi fa piacere citare un altro documentario che racconta gli stessi fatti attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti, è quello del 2012 di Simona Cappiello, Gli occhi più azzurri, cui è seguito l’omonimo libro nel 2018. Il documentario della Cappiello, come quello di Rinaldi, si trovano su internet e ci mostrano quel viaggio in treno, fisico ma anche simbolico, che avvicinò due ‘Italie’ distanti per lingua e cultura, nell’intento di dare una speranza ai bambini, la parte più indifesa della popolazione. Attraverso gli occhi di una giovane donna sulle tracce dei ricordi della nonna seguiamo, grazie a testimonianze, foto, filmati d’epoca e interventi di animazione, il filo rosso di quei treni, i racconti che affiorano, la memoria che permane per influenzare il presente. Oltre alle interviste ai bambini di allora, spiccano le testimonianze dell’ex sindaco di Napoli, M. Valenzi, di sua moglie, della senatrice comunista L. Viviani e del regista C. Lizzani.
E oggi questo splendido romanzo di Viola ne rafforza definitivamente il ricordo da tramandare con tenerezza per suscitare altre forti emozioni come quelle che hanno avuto e avranno i suoi lettori.
Vorrei aggiungere, per chiudere e non abusare della vostra cortesia, due ricordi personali legati alla mia famiglia. Tanti bambini è vero partivano, ma molti altri restavano qui a Napoli per i motivi più vari. Cosa fare? La Caritas napoletana organizzò le ‘colonie’, un mese al mare per i bambini più bisognosi con permanenza sul posto in strutture abbandonate ma utilizzabili. Mia madre, friulana, napoletana per amore, ne diresse tre a Portici a cui io ho preso parte e ne conservo un ricordo vivido.
Ancora, a Maddaloni un prete don Salvatore d’Angelo nel 1947 raccoglie in una caserma abbandonata bambini poveri, figli delle violenze di guerra, orfani di fatto e inizia l’attività del “Villaggio dei ragazzi” dove furono ospitati fino a più di mille ragazzi per vivere insieme, istruirsi, imparare un mestiere: suo braccio destro fu mio cognato.
È il caso di ripetere l’adagio “Meditate gente, meditate”. Vi ringrazio per l’attenzione.
Prof. Mario Di Giovanni
La scuola dell’inclusione ne Il treno dei bambini
Proviamo adesso a entrare nel vivo della storia, evidenziandone un frammento ben definito e particolarmente attuale.
Ci troviamo nella seconda parte del romanzo, una parte centrale all’interno dell’intera struttura narrativa. Viene qui raccontata una piccola grande trasformazione perché Amerigo, il protagonista del romanzo, arriva a Modena da Napoli e comincia una nuova vita al Nord. In ogni processo di trasformazione è importante, se non determinate, l’incontro con l’altro e per il nostro piccolo protagonista uno dei luoghi privilegiati di incontro e di confronto con l’altro è la scuola.
In un primo momento, come si legge nelle splendide pagine del libro, Amerigo non ha tanta voglia di andare a scuola: afferma di conoscere già i numeri e che le lettere non gli servono (sua madre Antonietta, infatti, non sa scrivere neppure il suo nome), inoltre non gli piace il grembiule perché sembra «un vestito da femmine», e lungo la strada che dalla nuova casa lo condurrà all’edificio scolastico chiede se ci sia realmente posto per lui, forse sperando in una risposta negativa.
È con questo stato d’animo che Amerigo affronta il suo primo giorno di scuola.
Nelle pagine in cui viene descritto l’incontro con il maestro e con i nuovi compagni di classe l’autrice mette in scena, con acuta semplicità, un meccanismo psicologico molto frequente: il pregiudizio. Entrambe le parti (Amerigo e i bambini del Nord) nutrono pregiudizi. Amerigo nota con sorpresa che «in questa scuola la maestra è un maschio e si chiama signor Ferrari» e che i bambini del Nord «sono tutti già ammaestrati» dal momento che eseguono le indicazioni del maestro senza protestare: «Il signor Ferrai dice: prendete i quaderni a quadretti e tutti li prendono; poi dice: Prendete i quaderni a righe e loro lo fanno». Dall’altra parte i nuovi compagni mettono subito alla prova Amerigo chiedendogli di rispondere alla domanda del maestro: «quanto fa due per sette?» e meravigliandosi della risposta corretta data da Amerigo. Per di più Benito chiamerà Napoli Amerigo e si tapperà il naso al suo passaggio, salvo poi diventare il suo compagno di banco e caro amico.
Anche i bambini, dunque, al pari degli adulti, hanno pregiudizi, ma allo stesso tempo hanno anche la straordinaria capacità di superarli, donando a noi adulti preziose lezioni di humanitas.
Il processo di trasformazione a cui facevo riferimento all’inizio si compie quando, durante il concerto di Natale, i bambini «sono tutti bellissimi ed eleganti e non si capisce più quali sono le creature arrivate dal Sud e quelle già del Nord».
Nelle pagine dedicate alla scuola la scelta del punto di vista ‒ condurre la narrazione attraverso gli occhi di un bambino ‒ acquista una particolare potenza espressiva e in esse, contemporaneamente alla trasformazione dei bambini, sembra realizzarsi la cosiddetta scuola dell’inclusione.
È a questo punto che emerge con forza l’attualità della storia raccontata. Anche oggi, infatti, c’è una diffusa emergenza sociale, economica, culturale e si parla spesso, come nelle sedi ministeriali così nei singoli istituti locali, di scuola dell’inclusione, racchiudendo in questa definizione la capacità della scuola di accogliere e celebrare le diversità: numerose classi, ad esempio, sono composte da alunni migranti di lingue e culture diverse.
Chiedo all’autrice, che è scrittrice ma anche insegnante, se la scuola, oggi più che mai, sa essere quel luogo privilegiato di incontro con l’altro, luogo di libertà e di trasformazione, di accoglienza e, perché no, di riscatto. Nel dire questo penso, con immensa tristezza, al bambino migrante morto in mare con una pagella cucita in tasca: quanto profondo e coraggioso era il suo desiderio di riscatto!
Se insegnare significa lasciare un segno, ringrazio di cuore Viola Ardone perché il suo romanzo ha lasciato un segno in tutti noi lettori.
Federica Caiazzo
Aspetti della lingua del romanzo di Viola Ardone, Il treno dei bambini
Nel suo bel romanzo Il treno dei bambini (Torino, Einaudi, 2019) l’autrice, Viola Ardone, si dimostra una scrittrice molto apprezzabile, non solo per le cose che ha scelto di dire ‒ la storia di un bambino dei quartieri disagiati di Napoli, Amerigo Speranza, le cui condizioni sociali e familiari lo fanno rientrare nel programma di affido temporaneo a famiglie settentrionali, promosso nel secondo dopoguerra (1946) dal Partito comunista a Napoli ‒, ma anche per averle detto in un certo modo, ovvero in una forma espressiva adeguata ai contenuti del racconto. Il treno dei bambini è infatti un romanzo originale e ben elaborato: la storia di povertà e di accoglienza, di solidarietà e di riscatto, è raccontata dal punto di vista del protagonista bambino, con toni commoventi e misurati, spesso anche ironici. In questo romanzo la scrittura presenta caratteristiche letterarie di un certo rilievo, per l’impegno profuso dall’autrice nella costruzione di una forma linguistica adeguata al contesto, ai personaggi e ai temi rappresentati, con fenomeni di grande interesse sotto il profilo della testualità e della sintassi, che caratterizzano in generale la lingua e lo stile dell’opera.
Uno dei modi per dare autenticità linguistica al racconto realistico è stata la ricerca di un tono popolare e dialettale, basso e colloquiale, verso cui è spinto il registro della lingua soprattutto nelle prime parti del romanzo. Il principio che la nostra autrice assume per la prosa realistica del racconto è quello infatti della verosimiglianza linguistica; un principio, com’è noto, che si afferma con i grandi romanzi dell’Ottocento italiano e in seguito sarà variamente declinato dai narratori del Novecento e oltre, fino alla recente narrativa. L’ottica della verosimiglianza modula stilisticamente il discorso orientandolo verso un tono semplice, lineare, comunicativo, un tono connesso con la simulazione nello scritto dei tratti della lingua parlata. Questa modalità è adattata sia ai dialoghi, sia al discorso interiore dell’io narrante, sia alle parti narrative vere e proprie, senza alcuno squilibrio stilistico nella forma della narrazione.
Un ruolo rilevante nella resa letteraria del registro dell’oralità nella lingua del romanzo è dato dall’incidenza del dialetto. Il napoletano rappresenta un ingrediente importante nella struttura linguistica, caratterizza fortemente la mimesi linguistica interferendo con l’italiano sul piano anzitutto del lessico e della morfosintassi. Notevole è la presenza di soprannomi espressivi e identificativi, che appartengono alle tradizioni linguistiche e culturali dei vicoli napoletani, e ricorrono senza particolari connotazioni dispregiative: Zandragliona (‘stracciona’), Pachiochia (‘bonacciona’), Capajanca, Capa ’e fierro; nomi di mestieri: verdummaro, chianchière, zarellàro, carnacottàro (p. 109) e, infine, solachianiello, quest’ultimo in concorrenza con scarparo (‘ciabattino’, ‘calzolaio’); parole comuni di largo uso non adattate o solo parzialmente adattate: alcune ben note anche fuori di Napoli, altre meno, come guaglione, monnezza, pacchero, scuorno, il frequentissimo metaplasmo capa, scucchia (‘mento sporgente’), pezze, alluccare, fatica e faticare, ecc.; infine, localismi di vario genere condivisi con l’italiano, come creature, che prevale su bambini presente nel titolo, oquello ‘appresso’ (nap. appriesso) dell’incipit del romanzo: Mia mamma avanti e io appresso.
Il dialetto agisce però anche a livello della morfosintassi e delle modalità enunciative della frase, caratterizzando con forza, in senso locale e regionale, la lingua del romanzo, con effetti, talvolta, di forme di mistilinguismo (code-mixing) di tipo espressionistico. Spesso nella costruzione degli enunciati, il confine tra i due codici sembra quasi scomparire: italiano e dialetto sono fatti sfumare l’uno nell’altro con grande disinvoltura, come avviene nel parlato quotidiano napoletano di registro basso e colloquiale: I compagni nostri del vicolo ci sfottevano, ci dicevano che parevamo due cape di morte uscite da dentro al Cimitero delle Fontanelle (p. 5).
Queste soluzioni linguistiche, che possono sembrare eccentriche, in realtà non risultano isolate nel quadro della lingua letteraria della recente narrativa. La lingua della prosa narrativa ha già da tempo rinunciato, per così dire, a rappresentare il cosiddetto baricentro della norma linguistica; costituendosi come modello uniforme e omogeneo, normativo e corretto, la lingua letteraria da sempre ha fatto da varietà di riferimento, ma a partire da Manzoni in poi c’è stato un suo progressivo avvicinamento al parlato e, ancora più recentemente, ai toni informali della lingua quotidiana, compresi quelli del dialetto.
Nella lingua di questo romanzo, la simulazione e la stilizzazione dei registri del parlato nello scritto comporta l’assunzione di fenomeni frequenti nella lingua del romanzo della recente narrativa, riconosciuti come tratti caratterizzanti il cosiddetto italiano dell’uso medio, ad esempio: fenomeni molto ricorrenti di tematizzazione, con spostamento o dislocazione a sinistra o a destra di costituenti della frase, con ripresa pronominale, per dare particolare enfasi espressiva agli elementi che si intende mettere in rilievo: Io la speranza la tengo già nel cognome, perché faccio Speranza pure io, come mia mamma Antonietta (p. 11); Per fortuna che pure all’amico mio gli fecero il mellone (p. 5); La vorrei vedere a quella capa ’e pezza (p.10); anche a me mi piace assai (p. 109); l’evitamento del congiuntivo: Mia mamma ci soffrì talmente che tutti pensavano che non si riprendeva (p. 11); Io pure sono ignorante, anche se dentro al vicolo mi chiamano Nobèl perché so un sacco di cose, nonostante che a scuola non ci sono più voluto andare (p. 12); costruzioni di verbi transitivi con la particella pronominale con valore enfatico-espressivo: Le madri si guardano ognuno i propri (p.30); se li teneva a tutti e quattro come apprendisti solachianielli (p. 33); Io di dottori non ne ho mai visti e non ne voglio vedere, però intanto mi mangio il pane (p. 36).
Questi fenomeni, che sono comuni alla lingua letteraria della recente narrativa, si ritrovano affiancati da caratteristiche linguistiche del napoletano. Il dialetto entra nella lingua del romanzo come carattere strutturante nella ricostruzione storica della materia narrata, per gli ambienti rappresentati e per il profilo dei personaggi. Il passaggio dalla lingua al dialetto avviene con molta naturalezza, con la ripresa di tratti specifici, ad esempio: l’impiego transitivo di una forma intransitiva di verbo, come avviene nel caso di ‘entrare’ costruito sul dialettale trasire, nell’enunciato entrare i panni stesi (pag. 11); la frequente posposizione dell’aggettivo possessivo: Donna Antonietta, pure voi ve lo vendete il figlio vostro?; io nella vita mia non ho mai cercato niente a nessuno (p.28); gli usi particolari delle preposizioni: uscite da dentro al Cimitero delle Fontanelle (p. 5); sopra a Pizzofalcone (p. 33); le frequenti occorrenze dell’accusativo preposizionale per l’oggetto diretto animato: Sentitemi a me (30); E adesso che ci siamo fottuti i cappotti, a noi come ci riconoscono più; infine, la sostituzione di avere ed essere con tenere e stare.
Ad una prima analisi, il modello di lingua realizzato potrebbe sembrare un modello trascurato, ma in realtà si tratta di scelte linguistiche orientate verso la riproduzione di fenomeni adatti a creare una varietà di base connotata localmente. Il modello, peraltro, non rimane lo stesso, è soggetto a variazione, a un cambiamento che accompagna e asseconda la crescita sociale, intellettuale, emotiva e affettiva dell’io narrante, Amerigo Speranza.
La struttura linguistica del romanzo è dominata infatti con abilità dalla nostra autrice, ed è condotta gradualmente, nell’ultima parte, verso un italiano mediamente colto. I tratti della varietà regionale, bassa e popolare, sintattici e testuali, che contrassegnano la scrittura delle prime parti, tendono a ridursi quantitativamente; si conservano alcune, per così dire, “tessere dialettali”, ma in ambiti piuttosto marginali, nel settore dell’onomastica, ad esempio, e con una funzione puramente referenziale (restano i nomi per evocare i personaggi e luoghi della storia), oppure nel discorso riportato, nelle battute di dialogo di quei personaggi del romanzo che continuano ad appartenere allo strato sociale originariamente di appartenenza di Amerigo Speranza, quello dei bassi napoletani, senza nessuna possibilità di un reale cambiamento. Nell’ultima parte del romanzo la lingua e lo stile sono condotti verso un tono medio; la pragmatica enunciativa continua ad accordarsi con la rapidità e una certa leggerezza della scrittura, con la presenza di frasi brevi, molto spesso di tipo nominale, e i modi comunicativi si avvicinano sempre più a quelli di un parlato colto, di un italiano mediamente colto. In sintesi, tutta la costruzione linguistica asseconda molto bene l’articolazione della narrazione, si adegua alle realtà rappresentate e alla complessità tematica, antropologica e psicologica espressa dai personaggi del romanzo. Lo stesso linguaggio che prevale, nelle prime parti, è quello della “implicitezza” e della allusività, caricate da una certa ironia: un linguaggio che trae il suo vigore espressivo dalle frequenti figure della similitudine e della metafora, adatte a rappresentare la visione del mondo di un bambino, ma anche a manifestare il legame intenso e lacerante che Amerigo ha con la madre, il quale fa, tra l’altro, da tema di fondo dell’intero romanzo.
Prof.ssa Rosa Troiano