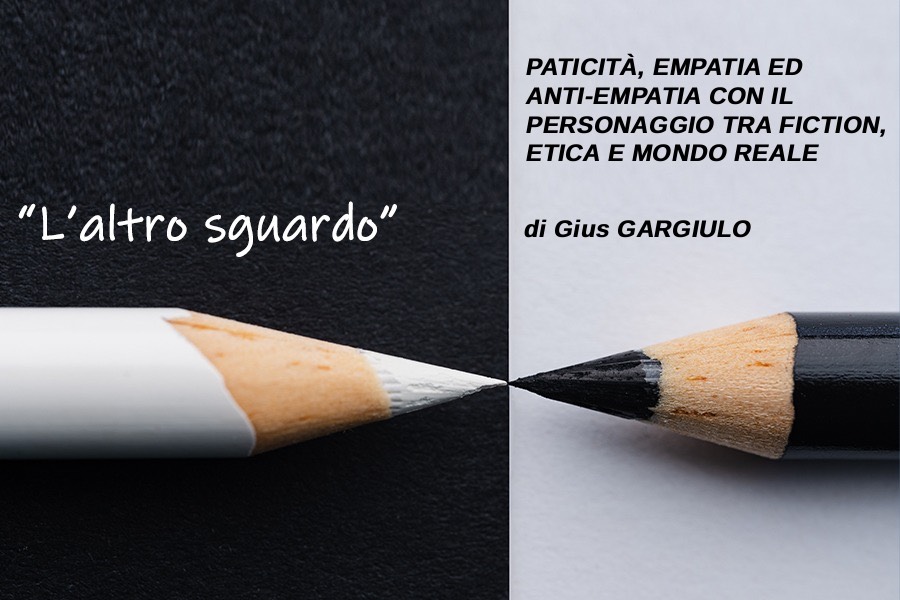di Gius GARGIULO
L’opera d’arte è il non ancora che irrompe con la sua unicità dal dialogo interiore perché avvenga la magia dell’incontro tra diversi vissuti rendendoli confacenti al bello dell’Intersoggettività. È un rovesciamento dell’alienazione. Della solitudine « dell’egoismo »…E ciò che Masullo desiderava per il suo Giordano Bruno (1).
Così, Nino Daniele, politico e intellettuale, in queste righe dense di concetti filosofici e ricordi affettuosi di una preziosa amicizia, ci spiega cosa hanno in comune un filosofo rinascimentale condannato al rogo nel 1600 e un pensatore del Novecento napoletano, raffinato interprete del nostro presente. Giordano Bruno e Aldo Masullo condividono un’intuizione profonda: il tempo non è un semplice orologio dell’universo, ma una forza viva, una dimensione problematica in cui si gioca il destino umano (2). Il tempo, per Masullo, è «condizione dell’etica»: non perché ci imponga leggi, ma perché ci mette in relazione, ci espone all’imprevisto, alla fragilità, alla responsabilità. Non si può essere etici fuori dal tempo: l’altro ci appare «nel tempo», e il tempo ci chiede di rispondere, di agire, di scegliere. In particolare, Masullo vede il pensiero come discorso, perché «tale lo costituiscono la parola, la mediatività, il tempo» (3) e il «tempo» viene pensato come patito (vissuto)perché scandito dal significato dell’irruzione della differenza. Il filosofo napoletano evidenzia le connessioni con l’esperienza vissuta e percettiva di ognuno, ossia ne chiarisce il senso come «paticità» o riflessione sulle emozioni nel momento o nel tempo in cui siamo colpiti o « feriti » consapevolmente dall’esperierienza del mondo esterno, soprattuto oggi dove una forma diffusa di indifferenza e superficialità anestetizza le emozioni. Nel saggio L’interminabile inquietudine dell’esistere, Masullo descrive l’essere umano come un «io temporale»: un’identità mai compiuta, sempre in bilico tra ciò che è stato e ciò che sarà (4). La concezione del «patico» o della «paticità» in Masullo rappresenta la riflessione sull’esperienza umana come esperienza dell’altro e come evento emotivo-affettivo prima che razionale (5). Quindi la paticità può investire anche il rapporto del soggetto con l’arte, il teatro e il cinema, poiché queste forme estetiche agiscono proprio sul piano dell’impatto emotivo e intersoggettivo, più che su quello del puro concetto. Nel saggio Il bisogno di amare, Masullo sottolinea che il sé non si costituisce da sé, ma si forma in un’esperienza relazionale che coinvolge anche l’affetto, la sofferenza, la cura (6). L’arte – e in particolare il teatro e il cinema, che lavorano sulle forme collettive della visione e dell’ascolto educano lo spettatore alla compassione, alla comprensione della vulnerabilità altrui. L’arte diventa allora una «pratica di resistenza umana»: ci ricorda che siamo esseri che patiscono e che, proprio per questo, possono amare. La scena teatrale e lo schermo cinematografico fanno vivere emozioni condivise, per creare comunità affettive temporanee tra spettatori e personaggi. Teatro e cinema non trasmettono solo storie, ma configurano mondi emotivi in cui lo spettatore è chiamato a entrare. Quindi il masulliano «non ancora » dell’arte, citato pertinentemente da Nino Daniele, si costituisce nel tempo vissuto, nella memoria e nell’attesa. Questo tempo vissuto è spesso messo in scena proprio dal teatro e dal cinema, che fanno dell’interiorità del personaggio un campo drammatico di possibilità, uno spazio di dolore, desiderio e trasformazione. In tal modo l’empatia prepara il patico, in quanto essa consiste nel far partecipare ai sentimenti degli altri (in particolare alla sofferenza, ma anche alla gioia o al piacere sessuale), che possono scatenare un atteggiamento di solidarietà o di rifiuto (in questo caso si parla di contro-empatia). La parola «empatia» è legata fin dalla sua origine al mondo teatrale in quanto deriva dal greco antico “εμπάθεια” (empátheia), a sua volta composta da en-, «dentro», e pathos, «sofferenza o sentimento», termine che veniva usato durante gli spettacoli teatrali per indicare il rapporto emozionale di partecipazione che legava l’autore-cantore e poi i personaggi interpretati dagli attori, con le loro alterne vicende, al pubblico che provava (Ἔλεος / Éleos) pietà o (Φόβος / Phobos) paura o terrore (7). L’empatia è diversa dalla simpatia che si riferisce, in senso lato, a un atteggiamento di benevolenza verso qualcuno. Questi brevi accenni sull’empatia messa in relazione di complementarietà con la nozione masulliana di «paticità», servono per introdurre il nostro discorso sul ruolo e sulla condivisione delle emozioni a livello estetico, filosofico, cognitivo e neuronale in rapporto all’«empatia» con il personaggio teatrale o cinematografico con il quale lo spettatore o anche il giocatore di videogame si sente in una forma di adesione e di accettazione del suo universo morale e di immersione nella dinamica «patemica» e quindi «affettiva», o di «anti-empatia» e di raffreddamento emotivo, tra pensiero e realtà del linguaggio, tra mondo della finzione e mondo del reale a cui la finzione di riferisce.
L’anti-empatia della «French Theory»: Barthes, Deleuze, Derrida e Baudrillard
La questione dell’empatia con il personaggio è uno dei temi più dibattuti, divisivi e teoricamente instabili delle teorie letterarie, teatrali e cinematografiche. Le motivazioni sono note, in particolare quelle politiche riguardanti l’eliminazione del ruolo centrale del personaggio da parte di autori e di critici. Il rifiuto di Brecht, ad esempio, per i fenomeni di identificazione era condizionato dall’efficacia della teatralità del regime nazista. Sulla scia del grande drammaturgo tedesco, Roland Barthes critica l’empatia tra attore e spettatore a teatro nell’interpretazione di Riccardo II di Shakespeare nel 1954, da parte del celebre Gérard Philipe, tendente a «lusingare l’inerzia dello spettatore», nel presentare un personaggio «tutto scorticato, disarticolato, spezzettato, ridotto e travasato come un alimento infantile o elementare, ingerito con la tettarella o la cannuccia» (8). Non meno dura è la critica all’empatia nell’ambito cinematografico con il riferimento al film Fronte del Porto (On the Waterfront) del 1954 di Elia Kazan con protagonista Marlon Brando. Il semiologo francese ritiene che l’ammirazione e l’amore immersivo per l’attore e per il suo personaggio, un intenso Marlon Brando che interpreta l’ex pugile e scaricatore del porto Terry Mallory, distragga lo spettatore da una critica obiettiva, rendendo la scena un esempio di alterazione della rappresentazione politica dell’intera opera (9). Ancora più virulenta, decenni dopo, la stroncatura di Brando nel ruolo di Paul, protagonista di Ultimo tango a Parigi del 1972, scritto e diretto da Bernardo Bertolucci, dove l’illustre semiologo condanna l’interpretazione in stile Actors Studio dell’attore americano colpevole a suo dire, di cercare solo la gloria personale (10). Barthes celebra la morte del personaggio in sintonia con gli autori del Nouveau Roman e dei critici del gruppo della rivista Tel Quel e della contestazione sessantottesca contro la società individualista borghese di cui la « tirannia » del personaggio è uno dei valori più evidenti sul piano simbolico. Il teatro negli anni Cinquanta in Francia costituiva una questione politica e polemica. I grandi intellettuali come Sartre e Camus scrivevano opere teatrali convinti che, con la scena, costituissero uno spazio critico di confronto e solidarietà. Questa concezione etico-politica è pienamente condivisa da Barthes. L’attore deve evitare l’empatia del suo personaggio con il pubblico eclissando il personaggio, per tendere ad una recitazione essenziale, spogliandosi del superfluo della spettacolarità ostentata nel compiacimento dello sforzo tipica del grande interprete applaudito dal pubblico, per il corpo e per la voce. Deve rinunciare alla «presenza» scenica di tutti i sentimenti che ha incarnato, per ottenere l’adesione empatica e poi catartica dello spettatore. Barthes non sopporta il teatro contemporaneo a cui contrappone il teatro greco antico e, più tardi, quello orientale, e attacca la recitazione verista o espressiva. Non gradisce l’attore ridondante nel suo sforzo apparente di divenire personaggio per cui l’impegno attoriale monopolizza ogni giudizio critico. L’attore ripete quello che il pubblico già conosce magari con qualche piccola variante, un teatro al servizio dell’esperienza dello spettatore piccolo borghese. Dall’attore di cinema a quello di teatro come abbiamo visto, la critica negativa del personaggio non cambia. Il teatro pensato e amato da Barthes è proiettivo e non protettivo di «affetto» e di sentimenti. Invece per Barthes in sintonia con le teorie di Gilles Deleuze e Felix Guattari dell‘Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie del 1972, opera che raccoglie gli echi della contestazione sessantottesca, la passione non deve essere una manifestazione dell’interiorità soggettiva e « individuale » di stampo freudiano dove il desiderio è concepito come mancanza e l’inconscio è un teatro che delira sui propri genitori con la follia a dover essere ricondotta all’ordine, ma al contrario per i due pensatori francesi, è il mondo moderno in ambito sociale che deve essere interpretato anche in funzione della singolarità del folle e l’inconscio è quindi visto come un’officina, una macchina per rivelare e produrre il desiderio che si modella nella libera configurazione delle singole personalità e delle forze nel mettere la Storia in movimento(11). Quindi il personaggio non è più il centro della scena. Non c’è più un «io» coerente da cui far scaturire le emozioni. La passione diventa un evento di superficie, una variazione d’intensità che attraversa corpi, suoni, luci, parole. Nel teatro contemporaneo da Grotowski a Castellucci, da Jan Fabre a Rodrigo García, il corpo in scena non rappresenta, ma emette, produce forze. La passione non è ciò che si sente, ma ciò che accade al corpo: sudore, urlo, immobilità, vibrazione. Barthes, con Deleuze e Guattari liquidano l’empatia nel teatro e nel cinema tradizionali. Un’empatia spesso scaturita dall’interiorità emotiva del personaggio: amore, gelosia, paura, vendetta sono visti come sentimenti profondi che motivano l’azione secondo una logica aristotelica e psicologica della rappresentazione con il personaggio che agisce in base a ciò che sente. Anche nel cinema, in Barthes e in Deleuze il passaggio dalla narrazione classica caratterizzata dalla dinamica del conflitto causa/effetto di tipo hollywoodiano a quella moderna coincide con una crisi dell’interiorità psicologica (12). Come nei film di Antonioni, Resnais, Tarkovskij e Lynch le passioni non sono più «spiegate» non c’è bisogno di una «backstory» o di una motivazione esplicita o didascalica ma esse sono avvertite come modificazioni del tempo e dello spazio. Le immagini non rappresentano, ma intensificano la forma cinematografica a farsi veicolo delle passioni a discapito dei contenuti, attraverso il movimento lento dei corpi con respiri prolungati, suoni ambientali che coprono il dialogo. In questa prospettiva al posto dell’empatia la passione diviene un fatto di montaggio, di cambio di ritmo narrativo, di luce, di durata: il cinema non racconta sentimenti, li fa accadere nello spettatore. Tra denotazione e connotazione l’immagine, nella fenomenologia del piano sequenza e della profondità di campo, rivela la realtà dell’essere, quindi dell’esistenza come realismo ontologico, fuori dal tempo del racconto filmico come pure fuori da quello fotografico. Questa ontologia della fotografia e del cinema da André Bazin, il grande critico, fondatore dei Cahiers du cinéma, si sviluppa ed evolve fino al punctum nella fotografia, teorizzato da Roland Barthes. Nell’ambito dello studium (il codice di rappresentazione semiotica della foto), il punctum è il dettaglio che attira l’attenzione, non appare sempre alla prima visione anche se è già presente, deve essere aggiunto dallo spettatore alla foto, un campo non visibile, anche se non è propriamente un fuori campo nel senso del cinema. Questo punctum proprio della fotografia, Barthes lo ritrova essenzialmente nel cinema di Antonioni citato nella Camera chiara per Blow-up del 1966 (13). Barthes, poco prima di morire, nel 1980, nella celebre lettera «Cher Antonioni…» con lucida ammirazione riconosce ad Antonioni la difficile arte di rappresentare il realismo autentico in tutta la sua instabilità di significati apparentemente invisibili. Antonioni è colui che mette in crisi il senso, ne mostra la sua «incertezza» come nel Grido del 1957, permettendo di scuotere «le fissità psicologiche del realismo», in Deserto rosso 1964, nell’Eclisse del 1962, dove gli affetti tormentati dei personaggi «sfuggono alla cornice del senso che è il codice delle passioni». Inoltre, Barthes, prima di Deleuze vede nel regista ferrarese la capacità di cogliere i vuoti o gli interstizi vuoti nei pieni nell’oggetto rappresentato «nel raro momento in cui la pienezza della sua identità precipita bruscamente in un nuovo spazio, quello dell’interstizio. In un certo senso, la vostra arte (di Antonioni, n.d.r.) è anche un’arte dell’interstizio (L’Avventura del 1960, sarebbe una dimostrazione lampante di questa proposizione)» (14). Proprio attraverso il cinema di Antonioni ripensato e riletto in questo modo virtuale e interstiziale da Barthes si passa alle riflessioni di Deleuze all’inizio del secondo volume di Cinema 2. L’immagine-tempo del 1985, che mostra chiaramente come anche lo spazio, nel cinema moderno, tenda a farsi spazio vuoto, spazio filmico (15). In Antonioni, inoltre, per giungere a questa soggettività, le immagini diventano mentali in quanto «subiscono delle improvvise rotture di sequenzialità con un dosaggio minimo di atemporalità (trad. mia)» (16). L’estetica teorizzata da Deleuze diventa in questo modo una fenomenologia dello sguardo per fare acquisire all’occhio questa funzione di veggente dove gli elementi dell’immagine, non solo visivi ma anche sonori, entrano in relazioni interne che fanno sì che l’intera immagine debba essere «letta», non meno che vista, leggibile oltre che visibile in quanto è la «letteralità» del mondo sensibile che la costituisce come libro. La «leggibilità» della narrazione attraverso le sole «sequenze oggettive» di immagini viene ribaltata da questo concetto di circuito e scambio, che introduce nell’analisi, il vasto campo della virtualità come azione fantasmatica perché ogni immagine implica la simultanea presenza di ciò che essa non è, proprio come ogni inquadratura determina un fuori campo, presente nello stesso istante, ma invisibile che non attiene alle esigenze più strettamente pragmatiche e narrative (17). Quindi più che di un «altro sguardo» c’è bisogno di un «doppio sguardo» di fronte all’immagine. In questo modo anche gli attori diventano lettori e spettatori attenti dentro i loro film, con un piede dentro e l’altro fuori della narrazione quando entrano ed escono dalle inquadrature con tanti saluti ad ogni forma anche minima di empatia con il personaggio. Questa digressione sulla concezione filosofica e psicoanalitica filmica di Barthes e Deleuze si rivela necessaria per poter comprendere e collocare il ruolo del personaggio e dell’attore decentrati e diminuiti nella visione del film trasformato in un’astrazione di lettura come quella di un libro per ritornare ad una fenomenologia della visione come análogon tra quello che si vede e quello che è nascosto, assente nella nostra coscienza e riportato in luce dalla «purezza» di un cinema d’autore e quindi intellettualmente aristocratico rispetto a quello che non lo è. Questi concetti sopravvivono ancora in tempi più recenti, tanto che il filosofo Alain Badiou afferma che seguire il protagonista nella narrazione dell’intreccio è un facile e illusorio accesso al percorso interpretativo del film, un errore fondamentale del cinema, quasi un peccato di pigrizia, mentre vedere un film per lo spettatore colto deve essere come leggere un libro, un atto mentale. dove, per Badiou, è l’immagine stessa nei suoi minimi dettagli a diventare narrazione (18). Da Bazin a Barthes e a Deleuze si nobilita il visibile con l’aiuto dell’intelligibile come pensiero filosofico. La legittimazione del visibile segue diverse strade: l’immagine, l’inquadratura, il montaggio per stimolare il pensiero critico. La ricerca dell’intelligibile sotto il visibile rappresenta un dualismo fenomenologico che ricorda quello metafisico, quasi un ritorno di Cartesio per un controllo totale delle emozioni contro ogni forma di empatia, ai danni di Spinoza fautore di stimoli emotivi appropriati per liberare emozioni positive e un benessere interiore. In effetti, questo mi sembra il punto nodale, filosofico e ideologico della critica cinematografica francese impegnata, detta «la cinéphilie», che mette in mostra una diffidenza nei confronti dell’immagine percepita dallo sguardo nella sua immediatezza malgrado l’interesse basilare sull’importanza della visione. Questa critica manifesta una cautela epistemologica verso l’immagine ampiamente condivisa che risale alla evidente volontà di «nobilitare» e avvicinare il cinema ad altre arti come alla letteratura e, soprattutto, alla pittura già negli anni Cinquanta con critici impegnati quali André Bazin e Jean-George Auriol, fondatore e direttore con Denise Tual, della Revue du cinéma. André Bazin loda questa illusione estetica della realtà nei film neorealisti di Rossellini e De Sica, nella profondità di campo e nel piano sequenza autenticamente realista perché rispetta la durata della realtà con gli eventi che si svolgono liberamente di fronte all’obiettivo. Bazin considera il Neorealismo come il primo movimento a dichiarare una scomparsa radicale dell’attore, della storia narrativa e della messa in scena così come erano praticate fino a quel momento, per giungere all’illusione estetica perfetta della realtà: capace di eclissare il cinema stesso. Nella «scuola italiana della Liberazione» Bazin trovò esattamente ciò che meglio realizzava il suo approccio al cinema attraverso processi cinematografici raffinati, emozione contenuta, accuratezza di ciò che viene mostrato e rispetto per l’ambientazione e per la sua complessità, come scrive in Che cosa è il cinema? (Qu’est-ce que le cinéma ?). Pubblicato postumo, la sezione è interamente dedicata al cinema italiano con il titolo : Una estetica della realtà : il neorealismo (19). Questo testo, fondamentale per comprendere l’idea di cinema di Bazin, al tempo stesso «etica ed estetica» come afferma Vincent Amiel (20), è illuminato e attraversato dalle riflessioni di Sartre sulla percezione mentale delle immagini teorizzate come opposizione categorica tra percezione e immaginazione, quasi un debito residuo nei confronti del dualismo cartesiano,nel saggio: Immagine e coscienza. Psicologia fenomenologica dell’immaginazione (L’Imaginaire : psychologie phénoménologique de l’imagination) (21). Libro del 1940, di stampo fenomenologico husserliano dove il mondo della percezione sensibile era in ultima analisi riducibile alle relazioni intellettuali e alla conoscenza scientifica. Il saggio sartriano è presente nella biblioteca di Bazin con numerose annotazioni da parte del celebre critico e viene considerato da Hervé Joubert-Laurencin, curatore dell’opera omnia del fondatore dei Cahiers du cinéma, una delle fonti primarie del pensiero baziniano, con l’affermazione del primato della realtà nella rappresentazione cinematografica, nel paragrafo introduttivo Ontologia e linguaggio sui fondamenti ontologici dell’arte cinematografica o, se si vuole, in termini meno filosofici: il cinema come arte della realtà.
Il doppio del linguaggio come anti-empatia
In questo modo Bazin poneva anche la travagliata questione della tecnica e del linguaggio del cinema in rapporto alla realtà rappresentata. Infatti, l’«illusione estetica» baziniana è dovuta alla capacità riproduttiva del cinema nel mostrare le ambiguità della realtà stessa attraverso il realismo considerato eminentemente un problema di linguaggio che solo alcuni registi riescono ad utilizzare ai fini di una maggiore aderenza e messa in discussione tra cinema e realtà. Come si vede è un problema di non poco conto dal momento che se la realtà ha un primato ontologico ne consegue che il linguaggio, a partire da quello naturale ha un ruolo determinante nello stabilire questa differenza. Se io dico nell’ambito della denotazione : «vedo un cane» oppure «ho visto un cane», usando il tempo verbale al presente o al passato prossimo dell’indicativo, essi sono già diacronici nel momento in cui formulo la frase, perché separo il cane di cui parlo da quello a cui mi riferisco nel mondo reale, che nel frattempo ha potuto fare anche una bella pipì ed essere andato via dal mio campo visivo e quindi non esistere più in rapporto a quello che esiste, «indicato-rappresentato» nella «realtà» della mia citazione-denotazione-discorsiva. Ancora più evidente il distacco-sdoppiamento-differenza, se aggiungo «vedo un cane che mi ricorda quello che avevo quando ero bambino». Tanto più, allora, il linguaggio connotativo della letteratura non può essere identificato con la realtà: esso ne costituisce piuttosto un «doppio», come sottolinea Michel Foucault, influenzato dalla lettura de L’Espace littéraire di Maurice Blanchot (22). In questo contesto, il «doppio» rappresenta una vera e propria ontologia della letteratura: un’istanza strutturale del linguaggio che opera uno sdoppiamento radicale del reale, anche quando si limita all’imitazione del mondo «trasfigura» ciò che raddoppia, destabilizzando i rapporti consueti tra originale e copia, realtà e rappresentazione. Trasferendo questa logica al linguaggio teatrale e cinematografico, Foucault individua un uso eminentemente «politico» della separazione tra parola, corpo, immagine e mondo. In questi ambiti, la rappresentazione diventa il luogo in cui si rende visibile quella che egli chiama «la grande storia dell’umanità», intesa come un labirinto invisibile di ripetizioni, sdoppiamenti e specularità (23). È in questa chiave che Foucault interpreta il celebre quadro di René Magritte Questa non è una pipa (Ceci n’est pas une pipe), esempio paradigmatico di una mimesi che non riproduce la realtà, ma ne produce un’altra, dotata di forza ontologica, autonoma, che raddoppia il reale senza mai coincidere con esso. L’atto stesso di «reduplicare», ovvero di moltiplicare il senso mediante la finzione, la distanza o la maschera, assume per Foucault un valore profondamente critico e rivoluzionario: è attraverso questa scissione interna del linguaggio che diventa possibile disarticolare i dispositivi di verità e potere (24). Questa concezione del linguaggio come realtà produttiva e performativa, che non si limita a rappresentare il mondo ma lo «costruisce», è stata ripresa, approfondita e radicalizzata da Judith Butler. La filosofa americana, pur in una prospettiva diversa, riprende da Foucault la centralità del linguaggio come spazio di costruzione dell’identità e come strumento di trasformazione politica. Anche per Butler, infatti, «il linguaggio è reale»: produce effetti materiali, istituisce soggetti, plasma corpi e relazioni, e agisce nel mondo come una pratica performativa, non semplicemente come una rappresentazione (25). Per Michel Foucault, la non coincidenza tra linguaggio e realtà ha radici storiche: essa nasce da processi di trasformazione epistemica che hanno ridefinito nel tempo i rapporti tra parola e mondo. In Jacques Derrida, invece, questa separazione è di ordine strutturale e ontologico: il linguaggio non può mai riferirsi direttamente a un «reale», perché ogni segno rinvia sempre a un altro segno in un gioco infinito di differenze («différance») neologismo concettuale coniato da Derrida a partire dal 1963, per indicare che la differenza «non abita il mondo ma solamente il linguaggio di cui è l’origine e la dimora»(26). Si tratta di una assenza che non è una astrazione. Può essere sperimentata, su uno dei palcoscenici della rappresentazione come il teatro. Ovunque, la «différance» frattura, sospende la presenza, incrina l’identità dell’io. Come si vede appare molto stretta la relazione tra la « différance » e il punctum dell’immagine elaborato da Barthes e, con le dovute « differenze » appare più chiaro il legame più fenomenologico che semiologico con la sua concezione del linguaggio teatrale collegato all’anti-empatia dell’attore. Queste concezioni di alterità, differenza, sdoppiamento e di valore ontologico della « realtà » del linguaggio, si avvicinano, e preparano il terreno – con le necessarie cautele epistemologiche – all’elaborazione della nozione di «simulacro» da parte di Jean Baudrillard. Nel pensiero di Baudrillard, si compie una vera e propria sostituzione ontologica: scompare la distinzione tra verità e falsificazione, tra realtà e finzione, tra esperienza quotidiana e spettacolo. Non si tratta di confusione, ma di coesistenza di due realtà distinte, parallele, autonome. Il mondo e la sua immagine non si riflettono più l’uno nell’altra, ma si rispecchiano fino a confondersi: entrambi esistono come realtà autosufficienti. Una volta che la rappresentazione – sia essa linguistica, artistica o performativa – viene separata dal referente reale e dal coinvolgimento empatico che la ancorava all’esperienza vissuta, si apre lo spazio teorico del simulacro. Baudrillard, sviluppando alcune intuizioni di Barthes e riprendendo criticamente la diagnosi situazionista di Guy Debord sulla società dello spettacolo, afferma che il simulacro non è ciò che nasconde la verità, bensì la verità che nasconde l’assenza di ogni verità: non c’è più nulla da svelare, perché non c’è più un’origine da cui si possa derivare un senso. In questo contesto, il teatro postmoderno diventa emblema del simulacro puro: non rimanda a nulla di esterno, non rappresenta più un mondo possibile, ma produce segni autoreferenziali, senza referente, è per sua natura una macchina simulacrale: esso mette in scena ciò che non è realmente presente: azioni, emozioni, mondi, ma che, proprio in quanto messa in scena, questo tipo di teatro rivela il carattere fittizio e instabile di ogni rappresentazione. Il segno teatrale diventa così un’illusione consapevole della propria inconsistenza, uno spazio vuoto che non cela un significato ma lo dissolve. Con il dramma borghese, il naturalismo o il teatro psicologico di Ibsen e Čechov, la rappresentazione comincia a mascherare la propria artificialità: si vuole far credere che sia vera quindi per Baudrillard l’immagine nasconde la verità, pur dipendendo ancora da essa. Ritengo che in questa definizione del filosofo e semiologo francese, faccia da collegamento e da anticipazione del postmoderno il teatro di Pirandello che ha rappresentato la pazzia come rifiuto della gabbia delle convenzioni sociali, la crisi dell’identità del soggetto e dell’univocità del reale e con «il teatro nel teatro» ha smascherato la stessa convenzione teatrale. Proprio in Sei personaggi il legame tra l’instabilità dell’«io» come individuo, il carattere fittizio della realtà e la realtà degli esseri finzionali diventa ancora più esplicito e apre con la «maschera nuda» a quella che sarà per Baudrillard la visione della realtà sociale contemporanea come il risultato di un processo di simulazione e sostituzione che termina nello stadio in cui il «Simulacro» smette di essere copia della realtà distaccandosene in toto. Da questa prospettiva sono gli autori del teatro « postmoderno» a giocare a carte scoperte con la finzione libera di divenire produttrice di se stessa per marcare un fallimento dell’emozione e dell’individualismo come nei casi di Heiner Müller, l’autore di Hamletmachine e eretico continuatore di Brecht (27), Sarah Kane autrice del violentissimo Blasted e di Cleansed, ispirato dalla lettura dell’opera di Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso dove finzione e riflessione, scena e quadro si confondono(28), Jan Fabre che unisce teatro e danza con effetti particolarmente choccanti per scatenare la passione nel pubblico in fuga dall’empatia con immagini crude, corpi nudi, sesso, scatologia e violenza(29) o Romeo Castellucci, l’autore della Tragedia Endogonidia, chefonda un teatro sulla totalità delle arti come la musica, la scultura, la pittura o l’architettura e rivolto a una percezione integrale dell’opera in un linguaggio comprensibile(30). Con questi artisti controversi il teatro smette di voler rappresentare «il mondo» e propone esperienze simulacriche: immagini scollegate da una narrazione, citazioni fluttuanti, figure prive di referente chiaro. Lo spettacolo diventa un sistema di segni che rimandano solo a se stessi(31). Se ciò che appare non ha più alcun riferimento alla realtà, ridotta ormai a un rimando di segni, è il simulacro stesso a prendere consistenza e anche valore positivo. Nel teatro questa situazione di riproduzione mediata e dissimulata dall’attore risulta ancora più ambigua. Barthes rifiuta il corpo che desidera secondo la concezione del « corps-sans-organes » di Artaud che non è e non deve essere scena teatrale per creare il desiderio come sostiene anche Gilles Deleuze della Logique du sens (32)e poi in sintonia con Felix Guattari. Essi teorizzano, come Baudrillard, la decostruzione del personaggio naturalistico e la fine dell’illusione « referenziale » da parte dell’attore in proiezione « mimetica ». Anche le analisi semiotiche sul personaggio come tripla costruzione attoriale o addizione di componenti testuali, metatestuali ed extratestuali, elaborate della storica del teatro Anne Ubersfeld, mi sembrano muovere le stesse critiche sulla decostruzione della centralità empatica : attore personaggio spettatore(33). Il personaggio come « struttura intermedia » assume denominazioni diverse con l’evoluzione delle culture teatrali a partire comunque dal ruolo centrale del testo(34). Ritorniamo quindi alla problematica della lingua con la sua intrinseca teatralità e iconicità che l’attore barthesiano dovrebbe smascherare attraverso una dizione neutra, atipica, impersonale, una voce tragica che mostri un distacco dalle azioni e dai personaggi possibili per uno straniamento già di tipo brechtiano(35).
Il teatro « congelato» anti-empatico come negazione del teatro
A me sembra che il teatro e il corpo sono visti da Barthes in una affascinante nebulosa metaforica senza riferimenti al teatro nella sua tecnica di materializzazione scenica. L’autore di Mithologies teorizza uno statuto paradossale di un corpo vivo e presente che rimette in dicussione la « presenza » scenica stessa dell’attore che ha perso la sua evidenza per divenire una provocazione, un discorso aperto. Il semiologo francese, come appare evidente, opera una critica più filosofica teoretica che semiologica, dell’immagine del corpo che resiste all’ordine simbolico denunciando in questo modo i limiti del discorso (l’ordine o la norma discorsiva) e del linguaggio (in quanto corpo di un determinato individuo). In questo caso c’è quasi un richiamo al Merleau-Ponty di Segni dove si sostiene che «c’è la parola dotata di senso, che viene chiamata pensiero, e la parola mancata, che viene chiamata linguaggio»(36). Il problema allora non è quello di «distruggere » la narrazione ma di « sovvertirla », « dissociarla » per una catarsi « critica » che libera dalle passioni nello spazio cosmico del teatro classico opposto agli spazi interni e segreti del teatro borghese, in pratica una «anti-empatia». Lo spettatore in tal modo dovrebbe essere non solo destinatario ma protagonista della interpretazione induttiva e deduttiva della significazione teatrale come avviene nella decodifica del linguaggio naturale. Uno spettatore che mantiene una distanza dall’evento sulla scena, che deve scegliere criticamente i valori etici e artistici dell’opera-testo senza concessioni tecniche, estetiche e abbandoni empatici al personaggio.
Ora, è importante, è fondamentale che sia lo stesso spettatore ad assumere la funzione di demiurgo e a dire al Teatro, come Dio al Caos: questo è il giorno, quella è la notte, questa è l’evidenza tragica, quella l’ombra quotidiana. Lo sguardo dello spettatore deve essere una spada, e l’uomo deve usarla per separare il teatro e il suo altrove, il mondo e il suo proscenio, la natura e la parola(37).
E per meglio chiarire il ruolo demiurgico dello spettatore a teatro, nel passo successivo Barthes rafforza il concetto evocando per lo spettacolo teatrale, la nozione di «démêlement» nel senso di «svelare un enigma», che in questo contesto più vicino alla fenomenologia tradurrei con «disvelamento».
Lo spettacolo è questo, questo disvelamento («démêlement»), questa angoscia e gloria di una separazione costantemente conflittuale, questa lotta tra due spazi e questa nascita in un luogo chiaro dove tutto è finalmente compreso, fuori da un involucro cieco dove tutto è ancora ambiguo (trad. mia)(38).
I volti degli attori e le messe in scena tendenti all’astrazione – cifra distintiva degli allestimenti «éblouissants» del Berliner Ensemble di Brecht, diventano per Roland Barthes l’occasione per una riflessione critica sul teatro come forma espressiva(39). Questa riflessione sfocia, emblematicamente, nel saggio del 1960 intitolato Ho sempre molto amato il teatro… ma non ci vado quasi più (J’ai toujours beaucoup aimé le théâtre … et pourtant je n’y vais presque plus), con cui egli sancisce l’abbandono sia della pratica teatrale sia della critica, prendendo le distanze anche dalla redazione della rivista Théâtre Populaire(40). Dal punto di vista di una concezione «anti-empatica» dell’estetica teatrale, questo abbandono può essere letto come il segno di un impasse teorico: per Barthes, il teatro non riesce più a sostenere il progetto di un’astrazione totale, in cui il corpo dell’attore non sia più veicolo di emozione, ma diventi supporto formale e simbolico della lingua. In altri termini, il teatro, nella sua dimensione incarnata, si dimostra incompatibile con il desiderio barthesiano di fare del linguaggio stesso l’unico protagonista: una lingua che non rappresenti più, ma che agisca da sola, come soggetto assoluto della scena, senza mediazione empatica. Questa posizione si avvicina a un paradosso centrale della filosofia del linguaggio di Heidegger, in particolare nel suo In cammino verso il linguaggio (Unterwegs zur Sprache) del 1959. Il filosofo tedesco tenta di pensare il linguaggio non come strumento di rappresentazione, ovvero come mediazione tra soggetto e oggetto ma come evento di disvelamento: il linguaggio non dice qualcosa «sul» mondo, bensì lo fa emergere, lo «porta» alla presenza. Tuttavia, proprio nel momento in cui Heidegger tenta di «lasciare parlare il linguaggio come linguaggio», giunge alla consapevolezza che questo compito è strutturalmente impossibile: non possiamo uscire dalla rete semantica che ci coinvolge, perché siamo sempre già parlati dal linguaggio(41). Una simile aporia attraversa anche la riflessione teatrale di Barthes. Il corpo dell’attore, nel momento stesso in cui è presente sulla scena, produce inevitabilmente un effetto empatico. Il teatro non può sottrarsi alla dimensione sensibile della relazione con lo spettatore. In questo senso, ogni tentativo di realizzare una messa in scena «astratta», depurata dal coinvolgimento affettivo e ridotta a pura significazione, finisce per inciampare nella stessa contraddizione che ha segnato la crisi dello strutturalismo narratologico: l’illusione di poter separare la forma dalla sostanza, la sovrastruttura simbolica dalla struttura materiale e percettiva. Infatti, come dimostra anche l’esperienza della ricezione teatrale, è impossibile cancellare del tutto la separazione tra autore e lettore, tra attore e spettatore, tra interprete e pubblico. Per quanto si voglia annullare ogni partecipazione diretta, lo spettatore continua a reagire, a proiettare, a sentire. L’interpretazione, nella sua efficacia, tende a rimuovere o a ignorare quella soglia che separa la scena da chi la osserva. Ed è proprio in questa soglia, in questa frattura non risolvibile, che si gioca ancora oggi la specificità dell’esperienza teatrale. Il sogno di Cecilia la povera spettatrice cinematografica innamorata del personaggio di Tom Baxter, protagonista della Rosa purpurea del Cairo (The Purple Rose of Cairo) di Woody Allen del 1985, che la invita a lasciare il suo posto in sala per farla entrare nello schermo e nella storia rappresentata nel film, è la visualizzazione metaforica di ogni empatia spettatoriale valida per il cinema ed anche in modo più evidente e materiale per il teatro(42). Nonostante la valorizzazione iniziale da parte di Barthes del carattere eminentemente visivo del teatro nella sua immediatezza «patemica» cioè nella sua capacità di colpire emotivamente lo spettatore – e malgrado la sua definizione etimologica come ϑέατρον/théatron, luogo della visione derivato del tema di ϑεάομαι/theáomai: «guardare, essere spettatore», ciò che sembrava una novità per una tradizione francese fortemente legata al primato del testo, il semiologo francese non riesce a sottrarsi alla diffidenza per l’immediatezza dell’immagine scenica. Questo scetticismo, alimentato anche dalla sua ammirazione per il teatro brechtiano, lo riporta entro i confini di una consolidata eredità intellettuale francese: quella che, lungo tutto il Novecento, ha messo in discussione la presa diretta delle emozioni e dei sensi sulla conoscenza. Tale sospetto nei confronti del sensibile, infatti, affonda le sue radici nel moralismo seicentesco e nel dualismo cartesiano tra intelletto e percezione sensoriale. È in questa cornice che Barthes finisce per trattare anche il teatro come un oggetto da «raffreddare», da porre a distanza critica. Lo stesso atteggiamento si ritrova nella sua riflessione sulla fotografia, dove egli distingue tra lo «studium» – il codice culturale, il sapere implicito che ci consente di decodificare l’immagine – e il «punctum», quel dettaglio imprevisto che ci colpisce, ci punge, e ci connette a qualcosa che non è più presente: un frammento di tempo perduto, un’eco affettiva. La fotografia, così concepita, diventa un «teatro dei morti», un legame simbolico con l’oggetto scomparso. Jacques Derrida, commentando La camera chiara di Barthes, ha colto in questa distinzione il nucleo di un’esperienza spettrale: lo «studium» permette, per via metonimica, l’accesso a uno «spectrum», a una presenza assente, a un’immagine che non rimanda a un referente reale ma a un mondo mentale, sospeso tra visibile e invisibile. In questa prospettiva, il «punctum» diventa lo stimolo che riattiva lo sguardo e la memoria dello spettatore, il luogo in cui l’immagine non rappresenta più ma evoca, richiama, suggerisce(43). Come ha notato acutamente Marco Consolini, Barthes sembra voler utilizzare il teatro contro il teatro, negandone la natura viva e presente: lo congela come un’immagine fotografica, lo ferma come si ferma un fotogramma. Il teatro diventa così, per lui, un fantasma, una forma spettrale della rappresentazione(44).
Il ritorno dell’empatia del personaggio
Queste idee sul teatro e sul cinema dell’anti-empatia e talvolta dell’antipatia, hanno avuto, ed hanno ancora oggi, insieme a quelle della scuola di Francoforte sulla negatività dell’industria culturale, un grandissimo successo con un notevole influsso in ambito estetico e specialmente teatrale, dalla Francia in tutta Europa, ovviamente in Italia ed anche negli Stati Uniti. Fortunatamente, quella che gli anglosassoni chiamano «The French Theory» convive con una sana empatia per i grandi attori di cinema e di teatro che proprio perché amati per la presenza e la professionalità scenica attraverso i loro personaggi, potevano e possono comunque provocare oltre all’emozione estetica anche una riflessione intellettuale. Dall’altro lato dell’oceano continuavano ad affermarsi le esperienze del Group Theatre di Lee Strasberg sulla scia della rivoluzionaria immedesimazione di Stanislavskij, del naturalismo dell’attore e della libera volontà, il «free will», nel recitare anima e corpo, dopo un lungo lavoro introspettivo, per appropriarsi del personaggio. Questa recitazione era incarnata in modo esemplare, sia a teatro sia a cinema da Marlon Brando, da Montgomery Clift e da James Dean, ampiamente elogiati dalla critica per la loro carica realista e profondità emotiva del «method acting» tanto aborrito da Barthes e dalla «cinéphilie»(45). In anni di accanita e spesso necessaria contestazione del «contro tutto» e del «vogliamo tutto», si andava a teatro malgrado tutto, per immergerci con Mario Scaccia nei panni del Mercante di Venezia, o con una Manuela Kustermann in quelli di Amleto e si apprezzavano e si amavano senza vergogna le personalità multiple di attori di teatro di cinema e mattatori televisivi e i loro personaggi come Vittorio Gassman, Gigi Proietti e Walter Chiari. Quest’ultimo diventava quasi una mitologia di se stesso con tutto il rispetto per quella consolidata di Marlon Brando vituperato da Barthes. Una mitologia, quella del grande Walter fatta anche di divertenti aneddotiche sul fatto di essere un personaggio e attore personaggio. Anzi lo stesso Walter Chiari ha confuso il proprio autoracconto con un alter-ego fantastico nel suo delizioso libro Quando spunta la luna a Walterchiari, a metà strada tra romanzo e biografia, sdoppiato e triplicato al teatro, al cinema e in televisione con tutta la sua mitologia anche divertente, alimentata dall’esuberanza del suo corpo per veicolare le passioni dei suoi personaggi in empatia con il suo pubblico(46). Questa spiccata e riuscita duttilità interpretativa e quest’«aura» attoriale, ammortizzano e facilitano, credo, l’empatia dello spettatore con il nuovo personaggio e la nuova situazione drammatica interpretata da un noto attore. Anche lo stesso Dario Fo, malgrado la sua opposizione all’attore istrione «quello che sprigiona fiumi di carisma», vive di empatia(47) come Carmelo Bene, artefice dello spettacolo, attore totale che trasforma la sua presenza scenica in un evento artistico. Il ritorno del personaggio è, tra l’altro, un sintomo dell’invecchiamento di queste posizioni radicali «antiempatia». Sono state le teorie basate sulla risposta dei lettori e degli spettatori, le scienze cognitive e le teorie della fiction a far risorgere il personaggio negli anni Novanta. Questa rinascita critica è stata poi accompagnata dall’esplosione della cybercultura e degli universi virtuali, che hanno dato vita a nuovi personaggi, capaci di un’intensa circolazione transmediale e di generare relazioni di identificazione senza precedenti con Lara Croft, Super Mario e con altri eroi nati nell’ambientazione dei video game e provenienti da universi narrativi ampiamente trascurati dalla critica con lettori e spettatori, che concedevano ai personaggi una forma di esistenza. Inoltre, si sottolineavano i benefici dell’imitazione ludica in termini di apprendimento. Umberto Eco in Italia con Apocalittici e integrati del 1964, e con le traduzioni dei fumetti americani sulla rivista Linus, dal 1965, avea sdoganato i personaggi dei «comics» inserendoli a pieno titolo insieme a quelli dei romanzi di appendice con Il superuomo di massa. Retorica e ideologia nel romanzo popolare, del 1976, nello scaffale dei personaggi della letteraura colta. Inoltre con il Trattato di semiotica generale del 1975 e Lector in fabula del 1979, Eco aveva introdotto in Italia la teoria della semiotica a «Mondi Possibili» (Possible Worlds) ripresa da Thomas Pavel in Fictional Worlds del 1986, che dà alla analisi della fiction e del personaggio uno statuto completamente autonomo dalle referenze al mondo esterno ad essa(48). Comunque, al cinema, già dal 1972 con Il Padrino, il solito Marlon Brando in versione gangster e poi nei panni di Jor-El, padre biologico di Superman, nel film omonimo, seguito dalla Saga degli Skywalker, roboteJedi di Star Wars nel 1977 e da Indiana Jones nel 1981, annunciano il ritorno dell’avventura individuale, del personaggio per la gioia empatica degli spettatori mentre battevano in ritirata le teorie formaliste e testualiste e salivano in scena quelle dell’identificazione e dell’empatia, mostrando come esse cancellino la differenza tra persona e personaggio e diano origine a questo nuovo paradosso della finzione: la finzione è pienamente legittima solo quando i suoi tratti distintivi vengono cancellati. Anche il processo di identificazione è stato a lungo screditato, sia come pratica sia come strumento teorico, prima di riacquistare un certo valore nel campo degli studi sui media audiovisivi e sui videogiochi. Tuttavia, il concetto di empatia ha ampiamente soppiantato quello di identificazione, di pari passo con il declino della psicoanalisi di fronte alla concorrenza delle scienze cognitive. L’identificazione è un processo psicologico mediante il quale un soggetto assimila un aspetto, una proprietà, un attributo di un altro e si trasforma, totalmente o parzialmente, sul modello di quest’ultimo. Ad esempio, molti giovani giapponesi, uomini e donne, si vestono come personaggi dei Manga oppure nei casi di travestimento «crossdressed» ci si ispira a un personaggio femminile iconico desiderato da vivere e interpretare sul proprio corpo. Nel corso della storia, il potere modellante dei personaggi di fantasia sul comportamento e sulla rappresentazione di sé è stato illustrato in modi diversi, ma l’uso della finzione è sempre inteso in termini di identificazione. L’identificazione dell’attore o dello spettatore con un contro-modello morale assiologico è il motivo principale della condanna del teatro come, ad esempio, per il personaggio immorale ma seducente del veneziano Volpone, signore avaro quanto ricco, e del parassita Mosca, nella commedia Volpone di Ben Jonson rappresentata al Globe Theatre nel 1606.(49) I moralisti e i poeti del Seicento hanno fatto di tutto per contrastare la propensione all’identificazione, che emulava il comportamento di personaggi dalla moralità dubbia. L’identificazione caratterizza l’uso personale e collettivo che ne facciamo, con una notevole continuità nella storia. Un esempio di identificazione collettiva è quella con un leader come nei tragici casi più famosi dell’identificazione con i capi dello stalinismo, del fascismo e del nazismo. In linea con il processo secolare della finzione, la critica radicale mostrata nei confronti del personaggio nell’Europa del dopoguerra si basa, in modo piuttosto contraddittorio, sia sul rifiuto dell’individualismo sia sulla paura dell’alienazione dei soggetti verso personaggi negativi e distruttivi. Gli inquietanti personaggi da incubo Nosferatu, Caligari e Mabuse del cinema espressionista tedesco degli anni Venti del Novecento, confermavano l’identificazione come mezzo di controllo, spesso legata all’influenza della psicoanalisi(50). In quest’ottica, l’identificazione entra in conflitto con una concezione dell’arte come emancipazione rifiutata da Adorno. Egli la mette sullo stesso piano dell’intrattenimento di massa che riduce la distanza tra gli spettatori e le opere d’arte per le manipolazioni dell’industria culturale. Il filosofo francofortese finisce per opporsi anche alla concezione kantiana del piacere estetico disinteressato(51).
L’empatia come terapia necessaria
I contatti più stretti tra identificazione ed empatia li troviamo nella cineterapia che utilizza il cinema come strumento di crescita personale. Si tratta di una derivazione ben diversa e semplificata delle varie fasi dal «role playing» teatrale dello « psicodramma » terapeutico inventato dallo psicanalista Jacob Levi Moreno a partire dagli anni Venti del Novecento. Nella cineterapia, il terapeuta sceglie un film che possa affrontare tematiche specifiche, come ad esempio la solitudine, l’autostima, la maturazione del carattere o la gestione del dolore. Il film viene quindi proiettato durante una sessione individuale o di gruppo, dove il paziente o i partecipanti guardano attentamente la storia e i personaggi, cercando di identificarsi con le esperienze rappresentate. Le identificazioni con i personaggi possono essere di tipo negativo o positivo. Dopo la visione, il terapeuta guida una discussione in cui i partecipanti esplorano e spiegano le emozioni che sono emerse durante il film in rapporto al loro vissuto per lavorare su queste identificazioni, analizzarle e abbandonarle per altre capaci di eliminare o ridurre i comportamenti negativi o disfunzionali del paziente(52). L’empatia invece, come abbiamo detto all’inizio consiste nel provare i sentimenti degli altri che possono suscitare un atteggiamento di solidarietà. Un esempio emblematico in questo caso è quello della «medicina narrativa», un approccio diagnostico e globale che applica le competenze utilizzate nell’analisi narratologica della letteratura al colloquio con i pazienti in quanto sostiene che il modo in cui un paziente parla con il medico della sua malattia o del suo disturbo è analogo al modo in cui la letteratura offre una trama «plot» come una serie interconnessa di eventi, con personaggi «with characters» (il paziente e altri) ed è carica di metafore (modi pittoreschi, emotivi e simbolici di parlare). La conoscenza degli elementi narratologici della letteratura facilita la comprensione delle storie narrate dai pazienti così da incoraggiare anche la creatività e l’autoriflessione del medico per sviluppare una empatia solidale con colui che deve curare(53). A partire dagli anni Cinquanta, l’empatia è stata misurata attraverso interviste e test che hanno rivelato le reazioni fisiologiche (frequenza cardiaca, sudorazione, reazioni facciali), consentendo di sviluppare diverse «scale di empatia». Più recentemente, grazie alle tecniche di risonanza magnetica, si è scoperto che assistere o vedere una rappresentazione delle reazioni dei propri simili e dei primati attiva spontaneamente e istantaneamente le aree cerebrali legate all’imitazione e alle emozioni. La rapidità di questo processo suggerisce che l’empatia deve aver giocato un ruolo decisivo nel corso dell’evoluzione, come reazione riflessa che innesca la risposta appropriata in caso di pericolo: aiuto, solidarietà, fuga collettiva. La risposta empatica è quindi quasi del tutto involontaria. Secondo ricerche più recenti sul cervello, le reti neurali responsabili della rappresentazione e dell’imitazione dell’azione osservata (come dimostra l’attivazione della corteccia fronto-parietale che interagisce con la corteccia temporale superiore) comunicano con le aree limbiche (associate all’emozione, alla capacità del cervello di percepire e rispondere). La reazione non richiede necessariamente un contenuto mentale rappresentativo preciso, ma è simile a un effetto eco o specchio(54). I «neuroni-specchio» scoperti tra gli anni Ottanta e Novanta del XX secolo dai ricercatori dell’Università di Parma, Giacomo Rizzolati e Corrado Sinigaglia, sono cellule nervose del cervello che si attivano» quando vedono qualcun altro compiere un gesto(55). Per esempio, se guardiamo qualcuno che prende una tazzina di caffè, nel nostro cervello si attivano le aree necessarie a compiere esattamente quel gesto, anche se noi, nella realtà, poi non lo facciamo. Questi neuroni, quindi, «riflettono», come uno specchio quello che «vedono» nel cervello altrui. Questo «sistema specchio» è una facoltà del nostro sistema nervoso fondamentale per la comprensione e l’apprendimento» di funzioni cognitive complesse come l’acquisizione del linguaggio, la teoria della menteo l’empatia(56). Gli esperimenti mostrano un’attivazione di una risposta emotiva particolarmente intensa quando vengono osservate e imitate le espressioni facciali. Un risultato che conferma diversi esperimenti precedenti dove lo spettacolo del dolore e il mezzo cinematografico provocano le risposte emotive più intense(57). Se dalla neurologia ritorniamo al problema estetico della sensazione empatica vediamo che il punto essenziale è il legame consustanziale tra osservazione degli altri, imitazione ed emozione. La ricerca sull’empatia fornisce in definitiva una risposta alle perplessità espresse da Amleto alle prese con i sentimenti scaturiti dalla finzione espressiva dell’attore(58):
Non è forse mostruoso che un attore, soltanto per finzione, nient’altro che in un sogno di passione, possa piegare la sua anima a un concetto a tal punto che per effetto di quel sogno, il volto gli si copra di pallore; occhi in lacrime, aspetto stralunato, voce rotta, e l’intero suo gestire in perfetta aderenza a quel concetto? E tutto ciò per nulla!… Per Ecuba! Che cos’è Ecuba a lui, e lui a Ecuba, perch’egli possa piangere così?(William Shakespeare, Amleto, Atto II, Scena II traduzione di Goffredo Raponi)(59)
Amleto osserva un attore che, recitando una parte su Ecuba — la regina troiana che perse tutto nella guerra — si commuove profondamente: piange, trema, la voce si spezza. Ma ciò che colpisce Amleto è che tutto questo dolore non è reale: è pura finzione. L’attore soffre per un personaggio che non ha mai conosciuto e che non esiste davvero. Da qui il suo sconcerto: «Tutto questo… per Ecuba!» Come ci ricorda Françoise Lavocat che ha scritto un denso e documentato libro sui confini tra mondo letterario filosofico e cognitivo della finzione in rapporto al mondo reale, queste celebri battute shakespiriane meritano di essere rilette alla luce delle recenti ricerche sulle simulazioni percettive in relazione ai processi testuali. In questo passo, il funzionamento dell’empatia viene dimostrato e messo in pratica. Amleto descrive il complesso processo dell’emozione. Descrive e imita l’attore, in particolare la sua espressione facciale. L’imitazione raddoppiata del teatro nel teatro (un attore che interpreta Amleto che interpreta un attore) incoraggia gli spettatori a simulare mentalmente i gesti imitati, il che gioca un ruolo decisivo nella produzione di emozioni(60). Scoprire come funziona l’empatia risolve anche quello che è comunemente noto come il paradosso della finzione, esemplificato dal dolore che proviamo per il destino di Madame Bovary o di Anna Karenina, pur sapendo benissimo che non sono realmente esistite. Ma il «paradosso» e la «mostruosità», come nota Amleto, svaniscono se consideriamo che la qualità fittizia di Ecuba e Madame Bovary, non ha alcuna influenza sulla nostra risposta neurale e che la risonanza empatica è ciò che rende possibile la performance dell’attore e il contagio emotivo che provoca nel pubblico. Inoltre, come abbiamo notato, l’affermazione delle scienze cognitive a partire dagli anni Novanta, ha coinciso con una valorizzazione della narrativa senza precedenti nella storia del pensiero occidentale, e persino globale. Ha coinciso anche con l’affermarsi della cultura dell’empatia e persino della politica della «cura»(61). La società del benessere richiede anche un cambiamento nel modo in cui le persone si relazionano tra loro. Dobbiamo passare da una società individualista a una società di «cura»: la società si prende cura di te, ma anche tu devi prenderti cura degli altri e della società(62). Questa correlazione ci porta a considerare la narrativa in modo nuovo: impiegata per promuovere la premura verso gli altri, la narrativa si scopre salutare per l’individuo, la società e la specie. In effetti, quasi tutte le culture umane custodiscono una qualche forma di narrazione. Potrebbe esserci una ragione evolutiva dietro il bisogno di storie della nostra specie. Basandosi sulla biologia evolutiva, l’antropologia, la teoria della narrazione, la psicologia cognitiva, la teoria dei giochi e l’estetica evolutiva, il critico letterario Michael Austin, ha sviluppato il concetto empatico di «finzione utile», una semplice narrazione che svolge una funzione adattiva non legata alla sua accuratezza fattuale. Nel suo libro vediamo come queste finzioni utili svolgano un ruolo chiave nel calmare l’ansia opprimente che gli esseri umani sentono mentre la loro mente raccoglie ed elabora le informazioni(63).
Identificazione e empatia per l’immersione etica e cognitiva nel videogame
In definitiva, dal punto di vista della psicologia cognitiva, l’empatia probabilmente serve ad innescare l’immersione del lettore o dello spettatore e in particolare del giocatore di videogame. L’identificazione del giocatore con il personaggio nel gameplay in vista della vittoria non lascia in linea di principio spazio all’empatia per le vittime. Questa mancanza di empatia è la critica rivolta ai videogiochi più volenti come il famosissimo Grand Theft Auto, abbreviato in GTA, pubblicato da Rockstar Games a partire dal 1997. Il giocatore controlla un fuorilegge e la sua ascesa nella criminalità organizzata in alcune città della California. In pratica si trova ad essere al posto di un autentico delinquente e pensare e operare come lui in una società degradata urbana di giorno come di notte, dove le persone diventano quasi dei bersagli di questa violenza che deve essere rivolta unicamente alla sopravvivenza e al successo nell’ambito dell’organizzazione criminale. Comunque, ogni forma di gioco e in particolare di videogioco comporta una certa neutralità morale in vista di un risultato individuale. Altri giochi si sono orientati verso la solidarietà patemica, come nel caso del gioco I Am Alive (Sopravvissuto), conosciuto precedentemente come Alive, videogioco d’azione, sviluppato da Ubisoft Shanghai e pubblicato da Ubisoft. dal 2012. Si tratta di una avventura di tipo «survival», ambientata in una realtà alternativa distopica dove in una città in rovine, nessuno è a conoscenza di cosa abbia provocato tanta distruzione e il giocatore deve badare a sé stesso, affrontando molte avversità, e scoprire dove si trova la sua famiglia dopo un anno dalla catastrofe. Inoltre, durante il suo viaggio, Adam, questo il nome del protagonista, si trova spesso a dover scegliere se aiutare gli altri e salvare delle vite, o se preservare la propria per raggiungere più velocemente il suo obiettivo. Gli sceneggiatori del gioco hanno scelto di trovare un equilibrio tra giocabilità e moralità – in altre parole, una finzione morale come afferma Françoise Lavocat(64). Oltre al caso di I am Alive, un altro videogioco combina empatia e identificazione con la realtà storica : Assassin’s Creed, sviluppato e pubblicato da Ubisoft Montréal sotto la direzione di Patrice Désilets e Jade Raymond, a partire dal 2007. In particolare Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood e Assassin’s Creed: Revelations hanno sempre lo stesso protagonista, Ezio Auditore nella Firenze rinascimentale. Viene mostrato il suo passato anche attraverso un film di fiction introduttivo «Lineage», con attori reali che si muovono nell’universo digitale del gioco, facendo capire ai giocatori il passato tragico dei protagonisti che li spinge a sfidare le leggi e la società per vendicare o mettere in salvo i loro cari(65) Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood e Assassin’s Creed: Revelations meritano particolare attenzione dal punto di vista dell’empatia in quanto mettono il giocatore nei panni di Ezio Auditore protagonista della vicenda, per agire nella Firenze rinascimentale del 1476, all’inizio di una nuova era per gli stati italiani, dove sotto l’influenza di grandi menti, risplendono l’arte, la cultura e la scienza con una buona dose di avventure, duelli di una crudeltà storicamente ben ricostruita, attraverso guerre e congiure spietate per la conquista del potere. Milioni di giocatori si sono già immedesimati nella storia, che esplora le complesse vicende politiche che hanno caratterizzato il Rinascimento italiano seguendo Ezio nella Firenze, Venezia e Roma tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento. Questi tre episodi forniscono anche brevi note storiche sui palazzi, le città o sulle persone che i giocatori possono incontrare. Ogni insegnamento fortuito è di tipo ludico e passa in secondo piano rispetto al gioco e alla storia, senza trasformarsi in una soffocante esperienza educativa. Durante il gioco si crea un rapporto empatico e cognitivo con i personaggi storicamente esistiti con i quali si puo’ interagire. Tra le figure che fanno la loro comparsa in Assassin’s Creed: Brotherhood, emerge Caterina Sforza (1463-1509), una leader politica e militare, particolarmente bella e coraggiosa che ha combattuto in armatura impugnando la spada alla testa dei suoi uomini e si è guadagnata il soprannome di «Tigre di Forlì» durante l’assedio della città omonima nella guerra d’Italia del 1499-1504, quando comandava la guarnigione della rocca di Ravaldino, distinguendosi per un’eroica resistenza nei confronti dell’esercito francese e pontificio guidato da Cesare Borgia che aveva preso in ostaggio i suoi figli. I giocatori possono avere, attraverso l’avatar di Ezio Auditore, un’avventura amorosa con Caterina, se per coraggio e onestà riescono a interessarla, ed hanno anche la possibilità di incontrare e ricevere i preziosi consigli dello statista e filosofo politico Niccolò Machiavelli (1469-1527) rappresentato in modo filosoficamente e storicamente accurato, nel senso che non si sa bene da che parte stia durante le vicende del gioco. Uno dei personaggi più popolari della serie di Assassin’s Creed è un giovane Leonardo da Vinci, nel 1476 ha 24 anni, che fornisce al giocatore tutti i tipi di armi e gadget basati sugli schizzi e le descrizioni del vero Leonardo da Vinci. Un giovane e vivace Leonardo fuori dal cliché del vecchio sapiente barbuto e distante, è una delle carte vincenti di questa saga videoludica. Leonardo, in particolare, può rappresentare uno dei migliori esempi di combinazione di realtà e finzione in un’esperienza estremamente gratificante. Interagire, essere aiutati e diventare l’amico di uno dei più grandi geni dell’umanità non è affare da poco. La sua popolarità in Assassin’s Creed 2 ha dato il via a una serie di messaggi online in cui i giocatori si scusavano con Leonardo per non essere riusciti a entrare in contatto con lui nel gioco. «Credo che questo sia il modo in cui si capisce che si è davvero in sintonia con il mondo e i personaggi di un videogioco, quando ci si sente veramente in colpa per aver perso un quick time event»(66), ha scritto un giocatore con lo pseudonimo di Imperius Rix sul forum del sito di videogiochi, Giant Bomb, rivolgendosi al personaggio di Leonardo, affettuosamente chiamato «Leo». «Mi dispiace, Leo. Sai che ti voglio bene, fratello» («Sorry, Leo. You know I love you, bro»)(67). Anche altri giocatori hanno espresso il loro affetto per il grande artista e scienziato. «Amico, quando gioco a questo gioco, non posso perdere questa opportunità», ha postato il giocatore con lo pseudonimo di The Great Guero, in risposta a Imperius Rix. «Leonardo da Vinci è troppo fantastico per non condividere un’amicizia» Leonardo, salutiamoci da amici «Let’s hug it out, Leonardo».In questo caso l’esperienza videoludica appassionante nella costruzione del gameplay rivela anche una utile funzione didattica in quanto la componente educativa non è superficiale. Il senso di empatia del gioco con gli eventi e i personaggi storici mi ha spinto a utilizzare con ottimi risultati didattici la serie di Assassin’s Creed come strumento di apprendimento efficace della lingua e della cultura italiane, durante i miei corsi sulla Letteratura e sulla Storia del Rinascimento presso l’U.F.R. L.C.E. dell’Université Paris Nanterre, con studenti italianisti francofoni a partire dall’anno accademico 2010-2011, per immergerli nella vicenda videoludica e nella Storia come un entusiasmante viaggio nel tempo. In effetti, il gioco offre grande libertà di azione, si attraversano le città rinascimentali comprando medicinali, rifornendosi di cibo e di armi, si conoscono e si prevedono le azioni dei personaggi politici e si usa anche, durante le missioni, il deltaplano, una macchina volante ricavata dai disegni originali di Leonardo(68). Negli Stati Uniti, il collega Simone Bregni, Ph.D., professore di Italian language, literature and culture della Saint Louis University, nel Missouri, ha usato i videogiochi e in particolare Assassin’s Creed per insegnare le abilità linguistiche agli studenti tanto da attirare l’attenzione della prestigiosa rivista Variety(69). Ancora più empatici si sono rivelati i giochi ideati da David Cage, fondatore della francese Quantic Dream, autore, tra gli altri, di Omikron: The Nomad Soul, Fahrenheit, Beyond: Due anime e Detroit: Become Human e specialmente di Heavy Rain in cui Ethan, un padre malato e in crisi, dà prova di amore e coraggio attraverso una serie di prove crudeli a cui lo sottopone il killer che ha rapito il figlio Shaun. I videogiochi offrono quindi un’illustrazione del conflitto tra identificazione ed empatia in quanto la loro evoluzione è andata verso la presentazione di conflitti morali stimolanti con lo sviluppo di strategie volte a suscitare empatia e di conseguenza, a favorire l’immersione narrativa(70). Indubbiamente i videogiochi hanno caratteristiche diverse rispetto alla fruizione cinematografica e teatrale in quanto all’immersione nella storia aggiungono anche l’interazione. Giochi come Prince of Persia: the Sands of Time (2003) o Assassin’s Creed (2007) si basano su trame sofisticate, con finali sorprendenti o enigmatici e aperti che stuzzicano l’ispirazione esplorativa dei giocatori grazie ai progressi tecnici (velocità dei processori e capacità di immagazzinamento dei dati) che hanno anche permesso ai videogiochi di visualizzare immagini particolarmente attraenti e realistiche dei mondi. Per quanto riguarda l’empatia, essa ha fatto la sua comparsa anche nei giochi più recenti, soprattutto grazie a personaggi secondari come abbiamo visto, nel caso di Caterina Sforza (in Assassin’s Creed), o diversificando in qualche modo i compiti dell’eroe: ad esempio, le imprese di Ezio Auditore con l’assassinio di personaggi importanti compensati dal suo spirito di giustizia e dall’aiuto che occasionalmente offre ai cittadini ingiustamente oppressi, sempre in Assassin’s Creed. Quei giochi di rievocazione storica sono i più soggetti ad una critica della componente morale e a generare polemiche come è accaduto in Italia per un videogioco a carattere pedagogico: Gioventù ribelle «la Breccia», realizzato in collaborazione con il Comitato per le celebrazioni del 150esimo Anniversario dell’Unità d’Italia, l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e il Museo Centrale del Risorgimento. Ambientato nella Roma del 1870 poco prima della Breccia di Porta Pia, vede il giocatore nei panni di un bersagliere accampato a Villa Torlonia in procinto di partire per la sua delicata missione fino a poter sparare anche al Papa. Si tratta di un gioco «sparatutto» («shooter»), freeware, in prima persona, come si dice in gergo, perché l’inquadratura in soggettiva fa vedere solo l’arma del personaggio guidato dal giocatore per mirare e sparare ai nemici che ostacolano il compimento della sua missione. Stesse polemiche e critiche di stampa e giocatori sono già toccate ad un altro videogioco italiano Il Rosso e il Nero, del 2004 (realizzato dalla software house indipendente romana Black Sheep Studios s.r.l.) con intenti celebrativi e pedagogici, che tenta di ricostruire in forma di «sparatutto» la guerra tra Fascisti e Partigiani(71). Le scelte dell’ambientazione sono state criticate, a causa del fatto che nel gameplay sono posti sullo stesso piano i «rossi» ed i «neri» e si può scegliere indifferentemente di impersonare un partigiano o un fascista. La storia moderna e contemporanea italiana non si addice al videogame, funziona meglio in termini di gradimento e di vendite, quella rinascimentale grazie ai franco-canadesi di Ubisoft con Assassin’s Creed II uscito tra il 2009 e il 2010. Dal punto di vista empatico e morale nella logica del videogioco non fa differenza la componente morale risucchiata dalla dinamica immersiva e interattiva del gioco, come negli scacchi non fa alcuna differenza se vince il bianco o il nero. L’empatia, quindi, non è la qualità principale che ci si aspetta da un personaggio che può risorgere ad ogni nuovo inizio di una missione anche se ucciso precedentemente quindi con più vite, con la possibilità di salvarsi e ricominciare la partita poco prima della fine. Mentre il lettore costruisce mentalmente lo stato di cose stabilito dal testo; lo interpreta, ipotizza possibili sviluppi narrativi, corregge le sue previsioni, che non dipendono da lui ma dallo svolgimento predeterminato della narrazione, lo spettatore in maniera più diretta e veloce a cinema e a teatro compie le stesse operazioni mentali. Anche il giocatore può progettare un mondo fittizio, ma questa costruzione non è puramente mentale; egli modifica effettivamente lo stato delle cose nel gioco ed è responsabile, parzialmente o totalmente, dello sviluppo e dell’esito degli eventi che vi si svolgono come ci ricorda ancora Françoise Lavocat nel delimitare i confini tra immersione empatica e interazione nel videogame. Infine, il rapporto dei giochi e della fiction con la realtà è fondamentalmente diverso. La narrativa costituisce un riferimento o uno pseudo-riferimento, mentre i giochi sono un’azione. Stiamo quindi parlando di nuove combinazioni, per grado e natura, tra il reale, la finzione e il gioco, basate meno sul riferimento che sull’interazione. Anche se l’immersione e l’empatia li troviamo nella dinamica dei videogiochi, la componente ludica ne stabilisce un uso fondamentalmente diverso, sia dal punto di vista pragmatico che logico(72).
La recente «svolta cognitiva», ha dato un potente contributo alla centralità del personaggio focalizzato tra lettori, spettatori e giocatori e, più in generale, ha riconosciuto il valore basilare della fiction. Così, come per Cecilia, la spettatrice del film di Woody Allen, il risultato dell’empatia, con buona pace di Barthes e dei suoi illustri compagni di viaggio e mentori autorevoli, sarebbe il desiderio o la tentazione di passare dall’altra parte dello schermo o di saltare sul palcoscenico per salvare i nostri amati personaggi e con loro anche noi, il nostro benessere psichico insieme agli altri, o di entrare con il nostro avatar nel mondo incantato e spietato dell’avventura videogiocata per incontrare i nostri eroi e capire i nostri limiti e la nostra forza.
Conclusioni
Come abbiamo visto sommariamente, l’empatia ha il suo fulcro nella rappresentazione teatrale in quanto elemento vitale di un rapporto di scambio narrativo, cognitivo ed emotivo tra gli esseri umani tanto da essere oggetto non solo della riflessione estetica, ma anche della ricerca filosofica psicologica, cognitiva, pedagogica e terapeutica. L’empatia nel momento in cui è anche una manifestazione della cura per gli altri rientra nella sfera del «patico» senza il quale come ci dice Aldo Masullo l’uomo rischierebbe di non sentire gli altri, di perdere la sua umanità e di diventare soltanto un individuo senza volto, simile a tutti gli altri, di cui non si accorge e di cui non ha cura. Il senso della nostra esistenza con gli altri in una realtà o in una «fattualità affettiva» è:«darsi cura per e di qualcosa, vivere prendendosi cura di qualcosa»(73). La speculazione della filosofia francese sul linguaggio dell’empatia, specialmente nel campo del visivo, ha quasi la funzione di un’anamnesi intellettuale per la storia delle idee nella cultura europea del Novecento. Essa tende a mettere tra parentesi se non a sterilizzare la forte carica emotiva di una rappresentazione per meglio identificare e pensare il mondo e cercare di emendarlo dal «troppo» della passione in chiave rigorosamente razionalistica dove invece le culture filosofiche, tedesca e italiana specialmente, hanno considerato il «pathos» un elemento energetico per lo sviluppo del pensiero e dell’azione. Oggi, grazie alle nuove conoscenze sull’emozione e sul sentimento, l’empatia rientra a pieno titolo in quel progresso degli studi sul cervello che ci permettono anche di capire a che serve l’emozione nell’ambito della nostra evoluzione come specie, nel nostro relazionarci agli altri nella vita quotidiana attraverso il linguaggio. L’espressione attraverso la quale funziona l’empatia è quindi anche riconoscimento e costruzione del significato, poiché comprendo le mie parole solo perché sono pronunciate per l’altro, e il significato esiste nel mondo solo perché i gesti dell’altro estendono il mio corpo e lo abitano secondo una intenzione. Ritorniamo al teatro che con il linguaggio del corpo e della parola ci permette di interpretare l’essere umano nel mondo e quindi di giungere, con la colorazione emotiva, al significato più profondo dell’esistenza umana.
1)Nino Daniele, Aldo Masullo. La filosofia in soccorso dei cittadini. Seconda edizione ampliata, Napoli, Libreria Dante & Decartes, 2025, p.92.
2) È questo uno dei motivi per cui « Bruno nel suo tempo, c’è compagno, nel nostro tempo », ivi, p. 117 ; si veda anche Aldo Masullo, Giordano Bruno maestro di anarchia, Caserta, Edizioni Saletta dell’Uva, 2016.
3) Aldo Masullo, Piccolo teatro filosofico, Dialoghi su anima, verità, giustizia, tempo,Milano, Mursia 2012, p. 117.
4) Cfr. Aldo Masullo, L’interminabile inquietudine dell’esistere, Napoli, Guida, 2001.
5) Cfr. Aldo Masullo, Paticità e indifferenza, Genova, il melangolo, 2003.
6) Cfr. Aldo Masullo, Il bisogno di amare, Bari, Laterza, 1991.
7) Cfr. Empatia (sub voce), in «Enciclopedia Treccani online», https://www.treccani.it/enciclopedia/empatia/
8) Roland Barthes, Fin de “Richard II”, («Lettres Nouvelles», mars 1954), in ID, Ècrits sur le théâtre, textes réunis et présentés par Jean-Loup Rivière, Paris, Seuil, 2002, p. 63, ediz. Ital. Sul teatro, traduzione di Laura Santi, Roma, Meltemi, 2002, p. 82. Tutti gli scritti sul teatro in lingua originale francese sono ora raccolti in Roland Barthes, Œuvres complètes, Livres, textes, entretiens 1942-1961, édition établie et présentée par Éric Marty, Paris Gallimard, 2002, vol. I.
9) Cfr. Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957, p. 69; ediz. Ital, ID, Miti d’oggi, traduzione di Lidia Lonzi, Torino, Einaudi 1974.
10) Cfr. Roland Barthes, Diderot, Brecht, Eisenstein, («Revue d’Esthétique», 1973) in ID, Ècrits sur le théâtre, cit., p.337.
11) Cfr. Gilles Deleuze e Felix Guattari, dell‘Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Éditions de Minuit 1972; ediz. Ital. L’Anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, traduzione di Alessandro Fontana, Torino, Einaudi, 1975.
12) Cfr. Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Les Éditions de Minuit, 1985, p. 15. ed. it. Cinema 2. L’immagine-tempo, trad. it. di Liliana Rampello, Milano, Ubulibri, 1989.
13) Cfr. Roland Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Cahiers du cinéma-Gallimard-Seuil, 1980, p.134, ed. it. La camera chiara. Nota sulla fotografia, trad. di Renzo Guidieri, Torino, Einaudi,1980.
14) Cfr. Roland Barthes, Cher Antonioni…, «Cahiers du Cinéma», n° 311, 1980, pp. 9-11, ora in Roland Barthes, Œuvres complètes, tome 5 : Livres, textes, entretiens, 1977-1980, édition établie et présentée par Éric Marty, Paris, Seuil, 2002, pp. 900-905.
15) Cfr. Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, cit., p. 15.
16) Ibidem, p. 16.
17) Ibidem, pp. 9-12.
18) Cfr. Alain Badiou, Cinéma, Paris, Nova Éditions, 2010, pp.54-55.
19) Cfr. André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, Tome IV –Une esthétique de la réalité : le néo-réalisme, Paris, Le Cerf, coll. « 7e art», 1962, préface de Jacques Rivette, ora in André Bazin, Écrits complets II, Édition établie, annotée et présentée par Hervé Joubert-Laurencin, Paris, Éditions Macula, 2018, pp.2571-2583 ; ediz. ital. Che cosa è il cinema? Il film come opera d’arte e come mito nella riflessione di un maestro della critica, presentazione, scelta dei testi e traduzionedi Adriano Aprà, Milano, Garzanti, 1999.
20) Cfr. Vincent Amiel et José Moure, Histoire vagabonde du cinéma, Paris, Véndémiaire, 2020, p. 553.
21) Jean-Paul Sartre, L’Imaginaire : psychologie phénoménologique de l’imagination, Parigi, Gallimard, 1940 ; ediz. Ital. Immagine e coscienza. Psicologia fenomenologica dell’immaginazione, nuova ediz. a cura di Raoul Kirchmayr, Torino, Einaudi, 2020.
22) Cfr. Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955.
23) « Le grand labyrinthe invisible de la répétition, du langage qui se dédouble et se fait miroir de lui-même », Michel Foucault, « Le langage à l’infini », in ID, Dits et écrits, (1954-1988), tome I, Édition publiée sous la direction de Daniel Defert et François Ewald avec la collaboration de Jacques Lagrange, Paris, Gallimard, 2001, p. 281.
24) Michel Foucault, « Ceci n’est pas une pipe », in Dits et écrits, op. cit., tome I, texte n° 53, p. 663-678.
25) Cfr. Judith Butler, Excitable speech: a politics of the performative. New York: Routledge, 1997; ed. it. Parole che provocano. Per una politica del performativo, traduzione di Sergia Adamo, Milano, Raffaello Cortina, 2010.
26) Jacques Derrida, La voix et le phénomène, Paris, PUF, 1967, p13.
27) Cfr. Jonathan Kalb, The Theater of Heiner Müller, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
28) Cfr. Sarah Kane, Complete Plays, introduzione di David Greig, London, Methuen, 2001; ediz. ital. Sarah Kane, Tutto il teatro di Sarah Kane, a cura di Luca Scarlini, traduzione di Barbara Nativi, Torino, Einaudi, 2000.
29) Cfr. Sito ufficiale di Jan Fabre, https://www.troubleyn.be/fr
30) Cfr. Romeo Castellucci, Chiara Guidi, Claudia Castellucci, Epopea della polvere. Il Teatro della Socìetas Raffaello Sanzio. Amleto, Masoch, Orestea, Giulio Cesare, Genesi, Milano, Ubulibri, 1992.
31) Cfr. Jean Baudrillard, L’Échange symbolique et la mort, Parigi, Gallimard, 1976, Lo scambio simbolico e la morte, traduzione di Girolamo Mancuso, Milano, Feltrinelli, 1979, rist. 1984; 1990; 2009; 2015 ; ID, Simulacres et Simulation, Paris, Éditions Galiée, 1981
32) Cfr. Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Éditions de Minuit en 1969, ed. ital. Logica del senso, traduzione di Mario De Stefanis, Milano, Feltrinelli, 1976
33) Cfr. Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, Paris, Editions sociales, 1977; ed. ital. Theatrikón. Leggere il teatro, traduzione di Paola Stefanini Sebastiani, Roma, Euroma-La Goliardica, (1994) 2008, p. 146.
34) Cfr. Roberta Carpani, Una struttura intermedia : il personaggio, in Annamaria Cascetta- Laura Peja, Ingresso a teatro. Guida all’analisi della drammaturgia, Firenze, Le Lettere, 2003, pp. 127-128.
35) Cfr. Maurizio Zanardi, Un teatro popolare e difficile, in Antonia Lezza, Annunziata Acanfora, Carmela Lucia (eds), Antologia Teatrale, Napoli, Liguori, 2015, p.178.
36) Maurice Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard,1960; ed. it. Segni, Andrea Bonomi (ed.), traduzione di Giuseppina Alfieri, Il Saggiatore Milano 2015, prima edizione 1967, pag. 37.
37) «Or, il importe, il est capital que ce soit l’homme-spectateur qui assure la fonction de démiurgique et dise au Théâtre, comme Dieu au Chaos : ici est le jour, là est la nuit, ici est l’évidence tragique, là est l’ombre quotidienne. Il faut que le regard du spectateur soit une épée et que de cette épée l’homme sépare le théâtre et son ailleurs, le monde et son proscenium, la nature et la parole», Roland Barthes, Avignon l’hiver, («France Observateur», 15 avril 1954), in ID, Écrits sur le théâtre, cit., pp. 69-70. ; ediz. ital. Sul teatro, cit., pp. 87-89.
38) «Le spectacle c’est cela, c’est ce démêlement, c’est cette angoisse et cette gloire d’une séparation sans cesse combattue, c’est cette lutte de deux espaces et cette naissance d’un lieu clair où tout se comprend enfin, hors d’une nappe aveugle où tout est encore ambigu», ibidem.
39) Cfr. Roland Barthes, L’ébluissement («Le Monde»,11 mars 1971) in ID, Écrits sur le théâtre, cit., pp.330-331.
40) Cfr. Roland Barthes, J’ai toujours beaucoup aimé le théâtre … («Esprit», mai 1965), ivi, pp.19-22.
41) Cfr. Cristina Lafont, Sprache und Welterschließung. Zur linguistischen Wende der Hermeneutik Heideggers, Suhrkamp Verlag am Main 1994, english edition: ID, Heidegger, Language, and World-Disclosure, translated bu Graham Harman, Cambridge- New York, Cambridge University Press, 2000, pp.106-108.
42) La rosa purpurea del Cairo (The Purple Rose of Cairo), letteralmente: La rosa viola del Cairo.
43) Cfr. Jacques Derrida, Les morts de Roland Barthes, in «Poétique», n. 47, 1981, pp.274-279.
44) Marco Consolini, Lo spettatore adulto. Barthes e l’energia metaforica del testo, in «Riga», n. 30, http://www.rigabooks.it/index.php?idlanguage=1&zone=13&id=772&idantologia=819&idnumero=&idautore=
45) Per un ampio quadro delle grandi scuole recitative e dei più significativi attori del cinema mondiale, cfr. Maurizio De Benedictis, Acting. Il cinema dalla parte degli attori, Salerno, Avagliano, 2004.
46) Cfr. Walter Chiari, Quando spunta la luna a Walterchiari. Semiromanzo quasibiografico di Walter Chiari, Milano, Edizioni SIPIEL, 1974.
47) Walter Valeri, Dario Fo: il mestiere dell’attore, in «La macchina sognante» num. 15, in luglio 2019, http://www.lamacchinasognante.com/dario-fo-il-mestiere-dellattore-intervista-di-walter-valeri/
48) Cfr. Gius Gargiulo, Umberto Eco, in Alba Amoya and Bettina L. Knapp (Eds), Multicultural Writers since 1945. An A-To-Z Guide, Westport (Connecticut)- London, Greenwood Press, 2004, pp.187-188 ed anche Thomas Pavel, Fictional Worlds, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1986; ediz. Ital. Mondi di invenzione. Realtà e immaginario narrativo, trad. Andrea Carosso, Torino, Einaudi, 1992.
49) Cfr. Ben Jonson, Volpone, or The Fox, in Ben Jonson’s Plays and Masques, Richard Harp (Ed.), A Norton Critical Edition, New York & London: W. W. Norton, 2001.
50) Cfr. Siegfried Kracauer, From Caligari to Hitler. A Psychological History of the German Film, 1947, ediz. Italiana: Da Caligari a Hitler. Una storia psicologica del cinema tedesco, a cura di Leonardo Quaresima, Torino, Lindau, 2010.
51) Cfr. Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, 1970; ed. italiana Teoria estetica, a cura di Fabrizio Desideri e Giovanni Matteucci, Torino, Einaudi, 2009.
52) Cfr. Gary Solomon, The Motion Picture Prescription: Watch This Movie and Call Me in the Morning: 200 Movies to Help You Heal Life’s Problems, Santa Rosa CA, Aslan Pub 1995. Lo psicoanalista americano, con il suo libro iniziò a prescrivere la visione di alcuni specifici film sulla base dello stato emotivo dei propri pazienti e degli obiettivi che intendeva perseguire con loro, ad esempio in caso di una grave perdita di una persona cara, o di una lunga malattia.
53) Cfr. Rita Charon, Narrative medicine: A model for empathy, reflection, profession, and trust, in «JAMA: The Journal of the American Medical Association», 286 (15), 2001, pp. 1897–1902.
54) Cfr. Laurie Carr, Marco Iacoboni, Marie-Charlotte Dubeau, John. C. Mazziotta & Gian Luigi Lenzi, Neural Mechanisms of Empathy in Humans: A Relay from Neural Systems for Imitation to Limbic Areas, in John T. Cacioppo and Gary G. Berntson (Eds.), Social neuroscience: Key readings, New York, NY, Psychology Press, 2005, pp. 143–152)
55) Cfr. Giacomo Rizzolati e Corrado Sinigaglia, Specchi nel cervello. Come comprendiamo gli altri dall’interno, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2019.
56) Cfr. Jean Decety and Philip L. Jackson, The Functional Architecture of Human Empathy, in «Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews», vol. 3, n. 2, 2004, pp. 71-100; vedi anche: Vittorio Gallese, The “Shared Manifold” hypothesis: from mirror neurons to empathy,in «Journal of Consciousness Studies» vol.8. 2001, pp. 33-50.
57) Cfr. Smith Murray, Engaging Characters : Fiction, Emotion, and the Cinema, Oxford, New York, Oxford University Press, 1995.
58) Cfr. Françoise Lavocat: Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil, 2016, pp.354-357.
59) «Is it not monstrous that this player here,/ But in a fiction, in a dream of passion,/ Could force his soul so to his own conceit/ That from her working all his visage wann’d,/ Tears in his eyes, distraction in’s aspect,/ A broken voice, and his whole function suiting/ With forms to his conceit? and all for nothing!!/ For Hecuba!/What’s Hecuba to him, or he to Hecuba,/ That he should weep for her?». William Shakespeare, Hamlet, Act II scene 2,The Complete Works, Peter Alexander (ed.), London & Glasgow, Collins, 1960.
60) Cfr. Françoise Lavocat: Fait et fiction, cit., pp. 356-257.
61) Cfr. Frans De Waal, The Age of Empathy: Nature’s Lessons for a Kinder Society, New York, Crown, 2010.
62) Cfr. Patricia Paperman e Sandra Laugier (Dirs), Le souci des autres. Èthique et politique du care, Paris, Edition de l’EHEES, 2006.
63) Cfr. Michael Austin, Useful Fictions. Evolution, Anxiety, and the Origins of Literature. Lincoln, NE Nebraska. Series: Frontiers of Narrative, 2010; ed anche: ID, Reading the World, Ideas that Matter, New York, W. W. Norton & Company, 2015.
64) Cfr. Françoise Lavocat, Fait et Fiction, cit., p. 367.
65) Vedi Assassin’s Creed: Lineage una serie di tre cortometraggi prodotti nel 2009, da Ubisoft, sviluppatore del gioco, la cui trama anticipa le vicende narrate nel videogioco Assassin’s Creed II. I film sono stati diretti dal regista canadese Yves Simoneau. https://www.youtube.com/watch?v=K30xjPkIjhU
66) Nel mondo dei videogiochi, un Quick Time Event con la sigla QTE (traducibile in italiano come evento breve) è un momento in cui si mettono alla prova i riflessi del giocatore nel premere uno o più pulsanti con il giusto tempismo. L’uso dei Quick Time Event all’interno di alcuni tipi di giochi è elogiato poiché favorisce l’immersione nella trama, rendendo le sequenze action interagibili. Attualmente questo dispositivo, spesso anche criticato dai giocatori perché li distoglierebbe dal gameplay, è stao abbandonato. Cfr. Quick Time Event in «Wikipedia» (sub voce) https://it.wikipedia.org/wiki/Quick_time_event
67) Cfr. Jeremy Hsu, A Renaissance scholar helps build virtual Rome, NBC NEWS, 17,nov. 2010, https://www.nbcnews.com/id/wbna40224688
68) Cfr. Gius Gargiulo, Assassin’s Creed II, Gaming and Learning History as Immersion in Italian Renaissance, conferenza presso la «Canadian Association of Italian Studies» all’Università di Toronto nel 2018, ora in «Annali dell’Istituto Armando Curcio», III, 2021, pp.157-187.
69) Cfr. Stefanie Fogel, Students at Saint Louis University Are Learning Italian by Playing ‘Assassin’s Creed II, in «Variety», 20,Apr. 2018, https://variety.com/2018/gaming/news/assassins-creed-ii-school-1202776178/
70) Cfr. Françoise Lavocat, Fait et Fiction, cit., pp. 3689-369.
71) Illuminante, sul piano di un’identità italiana videoludica, l’articolo di Matteo Bittanti, 16 agosto 2006, sul sito Videoludica Saggio: Il Rosso e il Nero, tra simulazione e revisionismo, http://www.videoludica.com/gamestudies/2006/08/16/saggio-il-rosso-e-il-nero-tra-simulazione-e-revisionismo/
72) Cfr. Françoise Lavocat, Fait et Fiction, cit., pp. 333-368.
73) Flavia Ferrigno, Il patico e l’etico in Aldo Masullo, Tesi di laurea in Filosofia Morale, Università degli Studi Federico II di Napoli, Anno accademico 2017-2018, p. 18.