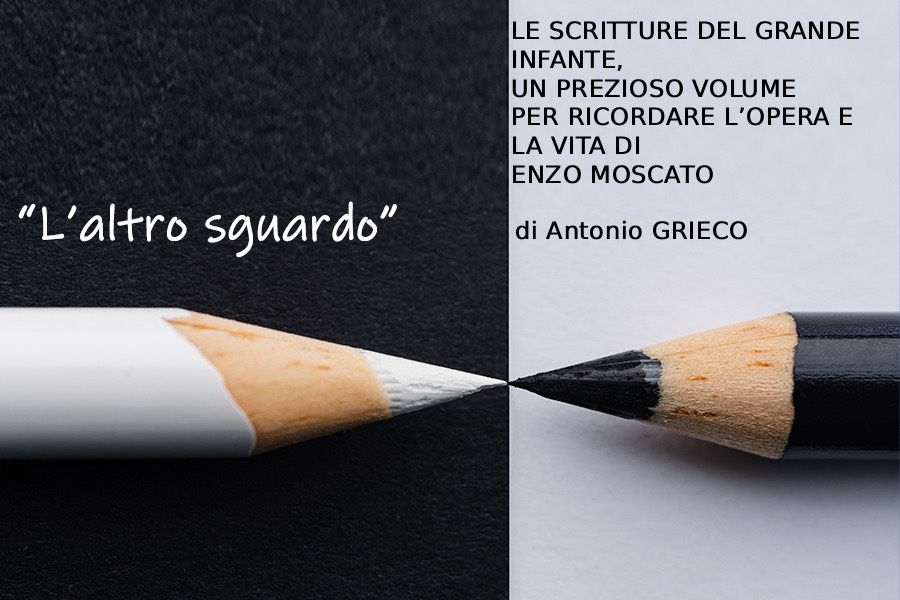di Antonio GRIECO
Le scritture del Grande Infante sull’opera – vita di Enzo Moscato, con testi di Gerardo Guccini, Antonio Latella, Antonia Lezza, Enzo Moscato, Matteo Palumbo, Maurizio Zanardi, è un volume (edito da Cronopio) imprescindibile per comprendere la poetica di uno dei più grandi autori italiani ed europei della scena contemporanea. Il motivo dell’indubbio rilievo di questo contributo alla conoscenza dell’opera di Enzo Moscato, risiede, a parer nostro, sia nella idea stessa del libro nata “in sua presenza” (poco prima della sua morte avvenuta nel gennaio del 2024), che per la pubblicazione in appendice di alcuni suoi testi inediti in cui sembrano affiorare gli elementi più vitali di una drammaturgia in cui, interagendo tra loro, si incontrano – in modo singolarissimo, a tratti surreale – poesia, tradizione, musica, religione, arte, filosofia (soprattutto lo sguardo eterodosso di filosofi francesi come Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze), dialetto napoletano, idiomi diversi. Di tutto questo il volume dà conto con grande puntualità, a partire da una indagine approfondita delle opere di Moscato, non solo quelle teatrali, che paiono scaturire tutte da una rigorosa decostruzione linguistica e, insieme, da uno sguardo costantemente rivolto all’Altro, a un mondo di esclusi da sempre ai margini della Storia; va inoltre detto che il linguaggio drammaturgico che nasce da questa costante interrogazione dell’arte scenica contemporanea, si richiama sovente alle nostre radici, alla stessa tradizione teatrale napoletana, ma sottraendone il già detto, lo stereotipo, quel modo ingenuamente naturalistico con cui talvolta, ancora oggi, viene ripresa e messa in scena. Dobbiamo dire che crediamo sia stato proprio questo complesso “corpo a corpo” di Moscato con la memoria teatrale della sua città a non essere compreso, agli inizi degli anni Ottanta del Novecento, da alcuni studiosi teatrali, anche tra i più attenti, del nostro Paese. Maurizio Zanardi ne parla nel suo saggio (Testi di godimento, pp.112 – 113), ricordando che egli fu oggetto di una severa critica da parte di uno dei più autorevoli critici teatrali del tempo, e che a difenderlo pubblicamente da quell’inaspettato attacco fu allora il solo Antonio Neiwiller, attore, artista, regista, tra i più originali protagonisti del nostro teatro sin dagli anni Settanta del Novecento. E, allora, per spiegare il motivo di quel gesto di rifiuto così netto della sua poetica, pensiamo sia utile soffermarsi, sia pur brevemente, sull’indirizzo prevalente nell’area della sperimentazione teatrale in quel decisivo passaggio d’epoca. Siamo, infatti, agli inizi degli anni Ottanta del Novecento – alla fine cioè di un lungo ciclo politico con qualche evidente segnale di restaurazione culturale in vaste aree della società civile – e il “ritorno al teatro”, dopo la crisi della post-avanguardia, sembra svolgersi secondo un indirizzo “spettacolare” in cui conta sempre più l’immaginario postmoderno globale e sempre meno il comportamento attoriale. Non a caso, proprio Giuseppe Bartolucci, l’autore della aspra critica rivolta a Moscato, a proposito di questo nuovo corso della ricerca teatrale italiana parlerà di “Nuova Spettacolarità” (si veda al riguardo, Giuseppe Bartolucci, Dalla post-avanguardia alla nuova spettacolarità, Roma, Bulzoni, 2007): l’idea cioè di uno spazio scenico dematerializzato, bidimensionale, che avvicini sempre più l’esperienza teatrale ad altre forme creative (e visive) globalmente diffuse e riconosciute, come il cinema, la televisione, i fumetti. Un approdo dunque virtuale all’azione drammaturgica, che però non convinceva attori-artisti come Leo de Berardinis (per il quale, come è noto, “Il teatro è l’attore”): persuaso, tra l’altro, quest’ultimo, sin dagli anni Sessanta-Settanta del Novecento, che la radicale messa in discussione dei codici tradizionali del teatro può avvenire all’interno stesso dello spazio scenico ( su questo si veda, in particolare, Attorno all’eliminazione del teatro, in «La scrittura scenica», n.3, 1971) e guardando – certo anche criticamente – alla Commedia dell’arte e all’immenso lascito dei nostri grandi maestri, come Raffaele Viviani e lo stesso Eduardo. Prendendo dunque le distanze da quella illusoria tensione spettacolare, che a teatro si avvaleva dell’utilizzo, talvolta eccessivo, della strumentazione tecnologica, nuovi autori attori napoletani come Annibale Ruccello, Enzo Moscato, Manlio Santanelli, lo stesso Antonio Neiwiller con la sua poetica visionaria e anti rappresentativa, diedero vita a Napoli, pur con drammaturgie tra loro molto eterogenee, ad un singolarissimo ciclo del nostro teatro di ricerca che si presentò sempre più come un consapevole, salutare atto di resistenza alla globalizzazione dell’arte scenica, dove la memoria, il corpo, la voce, il gesto attoriale, divengono parte costitutive di una teatralità diversa che aveva l’ambizione di tenere insieme tradizione e innovazione. Matteo Palumbo nel saggio che apre il volume (Conservare, ritornare, riscrivere, ricordare, p. 11), partendo da alcune opere come Archeologia del sangue e Scannasurice, si sofferma sulla straordinaria lingua di Moscato, che, guardando soprattutto ad Artaud, subisce nel tempo un radicale processo di trasformazione mutando in Lingua, carne, soffio. Ma restano sempre in Moscato, sia nei testi letterari che in quelli drammaturgici, nota lo studioso, frammenti di memoria e di vita vissuta tra i vicoli del suo quartiere – come appunto in Archeologia del sangue – “con il timbro di una suprema, elaborata partitura fonica”. Aspetto centrale della scrittura scenica del nostro maestro è poi, senza alcun dubbio, come accennavamo, il fondamentale rapporto con la Tradizione; rapporto assolutamente marginale, come abbiamo visto, nell’area della sperimentazione dei primi anni Ottanta. Questo elemento assolutamente costitutivo del suo teatro viene indagato con preziose illuminazioni critiche da Antonia Lezza, acuta studiosa del teatro di Moscato e Presidente dell’Associazione Centro Studi sul Teatro Napoletano Meridionale ed Europeo, nella cui sede per oltre dieci anni il drammaturgo ha tenuto seminari con giovani studiosi e attori teatrali. Al centro della investigazione moscatiana vi è, dunque, «il suo originalissimo rapporto con la tradizione, che Moscato stesso ha definito “tradinvenzione”» (Antonia Lezza, Neapolis: lingua, carne, suono. Appunti sulla tradinvenzione, p. 39); in definitiva, con questo particolarissimo modo di ripensare il teatro siamo in presenza di una sapiente rielaborazione del nostro passato teatrale che interagisce incessantemente con altre lingue, culture, suoni, idiomi, dialetti. Il risultato di questo approccio meditativo alla nostra drammaturgia è un linguaggio sottrattivo che, come sottolinea ancora Lezza, è presente in gran parte dei suoi testi, da Signurì, signurì, tratto da La pelle di Curzio Malaparte, a Chantecler, a La psychose paranoiaque parmi les artistes, una “tradinvenzione” di un saggio di Jaques Lancan, lo psichiatra francese, altro, ineludibile punto di riferimento di Moscato. Di grande interesse è in questo volume anche il contributo teorico di Gerardo Guccini (Moscato/Artaud: indagini su un dittico nascosto), che analizza la presenza del grande psicanalista d’oltralpe nella sua poetica, ricordando anche il poliglottismo del teatro moscatiano e l’incontro, nel 1996, con Leo de Berardinis al Festival di Sant’Arcangelo, che porterà ad una delle sue prime opere di argomento artaudiano: Lingua, Soffio, Corpo. (Moscato/Artaud: indagini su un dittico nascosto, p. 115). Il libro termina con un bel ricordo del regista Antonio Latella (Lettere a Te) – che parla del suo teatro come un’Opera-mondo” – e con alcune sue scritture sino ad oggi sconosciute, che ancora una volta danno la misura di quanto il nostro maestro abbia indagato “da straniero” quel magico luogo di confine che è il teatro: con uno sguardo – come egli stesso scrive nel testo inedito Intorno a ciò che si dice impossibile – su tutti coloro «che vivono situazioni-limite, sempre sul bordo, sempre sulla soglia trapassante di un’esperienza. Sono (o dovrebbero essere) quelli che non posseggono nulla, tranne la consapevolezza del loro non essere, della loro negatività, rispetto al centro… Gli attori sono (o dovrebbero essere) i portavoce dell’impossibilità costituzionale del teatro a essere sano. Perché, proprio in quanto negazione del valore, del valore-centro soprattutto, il teatro è non-norma, non salute, crisi e messa in crisi continua data dalla malattia»(p.182). Basterebbero queste parole a dirci quanto – anche dopo la sua scomparsa terrena e in questo triste tempo di inaudite barbarie – il nostro grande maestro continui a parlarci, ad illuminarci sulla necessità di mantenere sempre vivo a teatro quel sotterraneo, impercettibile filo rosso che attraversa l’arte e la vita.